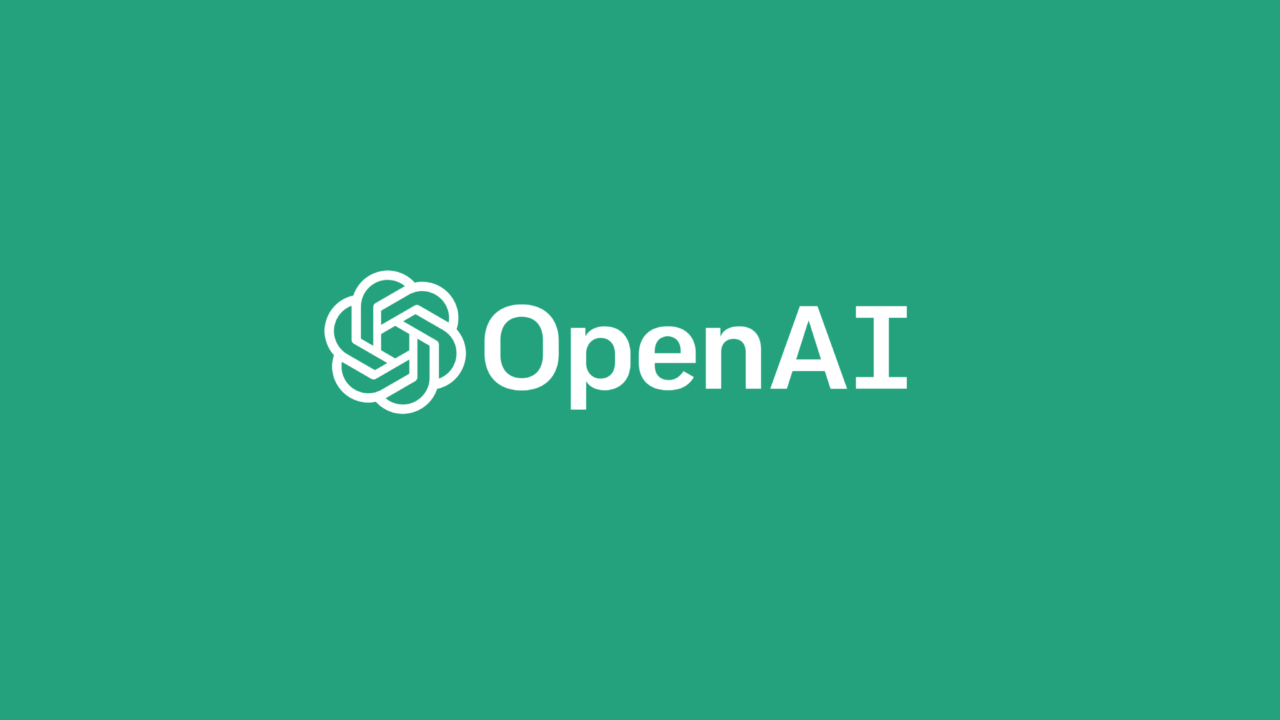Sembra quasi una barzelletta, ma la realtà è più intrigante di qualsiasi sceneggiatura hollywoodiana. Una commissione di saggi, vestita di buonismo tecnologico, ha deciso che OpenAI non basta solo a costruire chatbot evoluti e algoritmi sofisticati, serve anche un fondo d’emergenza per “salvare il mondo”. Ovvero per finanziare organizzazioni civiche impegnate in scienze della salute, ambiente e, ovviamente, la lotta contro la disinformazione dilagante provocata proprio dall’intelligenza artificiale. La cosa assume toni quasi ironici se si pensa che proprio la stessa AI, creata da OpenAI, sia uno degli strumenti più affilati in mano alla disinformazione digitale.
In fondo, la mossa non sorprende se si considera il quadro più ampio: OpenAI, pur essendo un’organizzazione no-profit, si prepara a un colpo da maestro finanziario con la trasformazione in società di pubblica utilità, potenzialmente aprendo il capitale azionario tradizionale a investitori esterni. Non è esattamente la storia di Davide contro Golia, quanto più un racconto di un gigante che cambia pelle e cerca di sedersi al tavolo dei grandi senza perdere la faccia da benefattore. Il fondo emergenziale proposto vuole essere un paracadute per chi, sul campo civico e sociale, rischia di affondare nelle nuove sfide tecnologiche e sociali portate dall’intelligenza artificiale.
Il rapporto della commissione, con i suoi 35 pagine di raccomandazioni, è un esercizio di stile e di strategia. L’idea è chiara: OpenAI non deve solo sopravvivere come entità tecnologica, ma deve spingere sull’acceleratore della responsabilità sociale, investendo parte dei miliardi potenziali nel mitigare i danni collaterali di quella stessa tecnologia che produce profitti immaginari ma potenzialmente illimitati. Interessante notare che, nonostante la promessa di enormi guadagni, la società non prevede di generare profitti reali per diversi anni, una tattica che fa pensare più a una partita a scacchi con il futuro che a una semplice gestione aziendale.
Nel frattempo, la proposta non è passata senza attriti. Gruppi di interesse variegati guardano con sospetto al piano di trasformazione, temendo che la componente no-profit, tradizionalmente garante della missione pubblica, possa venir “azionizzata” fino a perdere la sua essenza originaria. In questo scenario, il fondo di emergenza rappresenta un doppio atto: un meccanismo di protezione ma anche un messaggio di intenti. Qualcosa di simile a una promessa incisa in digitale: “Noi sappiamo che il potere dell’AI può essere pericoloso, e per questo mettiamo dei soldi a disposizione per arginare i rischi”.
Ironia della sorte, proprio nel momento in cui la governance tecnologica si fa più complessa, con capitali miliardari e interessi politici che si intrecciano, la parola d’ordine rimane “comunità”. È quasi nostalgico, se si pensa che l’intelligenza artificiale era nata con l’ambizione di sostituire l’uomo in molti compiti, e oggi finisce per dover “salvare” le comunità che rischiano di essere travolte da essa. Il rapporto della commissione OpenAI sembra quindi una risposta pragmatica, anche se non priva di contraddizioni, a un futuro in cui la tecnologia e la società devono imparare a convivere senza che l’una divori l’altra.
D’altronde, non è forse questa la sfida più grande della trasformazione digitale? Trovare un equilibrio tra crescita, innovazione e responsabilità, con un occhio vigile sui rischi sistemici e l’altro puntato su un possibile futuro sostenibile. La proposta di sovvenzioni di emergenza per le organizzazioni civiche non è solo un’idea gentile, ma una vera e propria scommessa sul ruolo che le entità non-profit devono giocare in un ecosistema dominato da giganti tecnologici e algoritmi capaci di modellare la realtà. Non fosse altro, vale la pena tenerla d’occhio come un laboratorio di politiche pubbliche e innovazione sociale, magari con un pizzico di sano scetticismo verso le promesse troppo grandi.