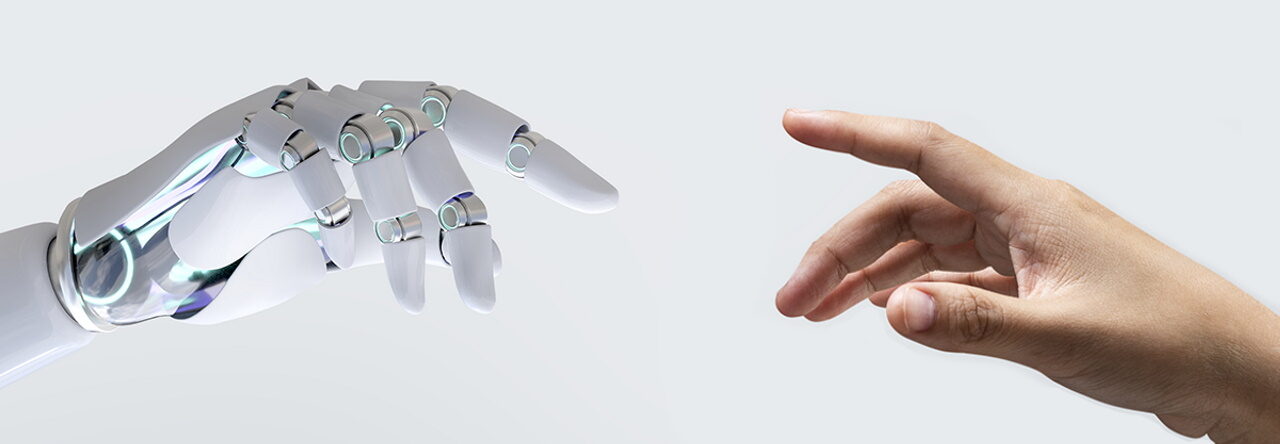C’è qualcosa di straordinariamente tossico nel dover spiegare, ancora oggi, che una corporazione non può essere sostenibile. Non nel senso profondo e autentico del termine. Non importa quanti Chief Sustainability Officer si sforzino di redigere report patinati pieni di foglioline verdi e parole come “net-zero”, “carbon offset” o “circular economy”. Per quanto tu possa voler bene a quei professionisti onesti, magari idealisti la verità resta nuda e impietosa: il loro lavoro è l’ecopittura murale dell’apocalisse.
David Graeber, antropologo e attivista statunitense di orientamento anarchic, morto nel 2020, con la lucidità dissacrante che lo caratterizzava, l’ha detto senza troppi giri di parole: le corporation non possono essere greenate. Non è un limite di volontà, è un’incompatibilità strutturale. Le fondamenta stesse del modello aziendale—l’accumulazione di capitale attraverso l’estrazione di valore dal lavoro umano e dal pianeta sono tossiche per la biosfera. Punto.
Il resto è spettacolo. Greenwashing ben coreografato. E quelli che lavorano nel “dipartimento sostenibilità” sono, loro malgrado, ingranaggi di una macchina che sa perfettamente di non poter cambiare direzione. Perché cambiare davvero significherebbe smantellarsi.
Ci vuole coraggio per ammetterlo, soprattutto se hai costruito la tua carriera dentro quella macchina. Ma se non siamo disposti a guardare in faccia la contraddizione, continueremo a perdere tempo, decennio dopo decennio, fingendo che basti “ottimizzare i processi” e “integrare l’ESG”. Intanto la temperatura sale, le risorse si esauriscono, e la disuguaglianza si avvita su se stessa come un vortice.
Serve un cambio di sistema. Ma quello vero, non le chiacchiere da boardroom o le startup che vendono la sostenibilità come se fosse una nuova linea di cosmetici bio. Serve legislare queste strutture fuori dall’esistenza, come scrive l’autore del post, e ripensare radicalmente il modo in cui organizziamo la produzione, la distribuzione e il valore. No, non è utopico. È semplicemente necessario.
Progetti come “Project Tipping Point” sono tentativi ambiziosi di costruire un ponte verso un altro immaginario economico. Non perfetti, certo, e sicuramente pieni di contraddizioni (come tutto ciò che tenta di agire dentro il vecchio mondo mentre costruisce il nuovo), ma almeno hanno il merito di affrontare il problema dalla radice. Linguaggio, dolore, imperialismo, immaginari, riti di passaggio… tutti temi che raramente entrano nei meeting ESG, e che invece sono il cuore pulsante del cambiamento.
Sì, il progetto costa. Sì, è ironico. Ma la critica al capitalismo non è la critica al denaro o allo scambio, come viene semplicisticamente ridotto da chi ha bisogno di caricature per evitare di pensare. Il capitalismo è accumulazione perpetua, estrazione sistemica, alienazione normalizzata. È il sistema che trasforma ogni cosa in merce, incluso il desiderio di salvarci.
Quindi no, non è un controsenso far pagare un corso sul cambiamento sistemico. È un controsenso aspettarsi che il cambiamento arrivi gratis, magari sponsorizzato da una multinazionale del petrolio pentita. O che basti un badge “B Corp” per lavarsi l’anima.
Il punto, alla fine, è che nessuna transizione verde è possibile finché la macchina capitalista continua a girare. Perché la sua logica interna non lo permette. È come chiedere a un predatore di diventare vegano. Può mimare il comportamento, ma la fame resta.
C’è un detto da bar dei daini, vecchio come il cinismo operaio: “se davvero volessero salvare il mondo, non ci sarebbe bisogno di budget marketing.” Forse è il caso di ripartire da lì.
Altro che corporate social responsibility. Serve una cultura della responsabilità sociale senza corporation. Serve una rivoluzione. E no, non in senso metaforico.
Benvenuti nel secolo delle scelte difficili.