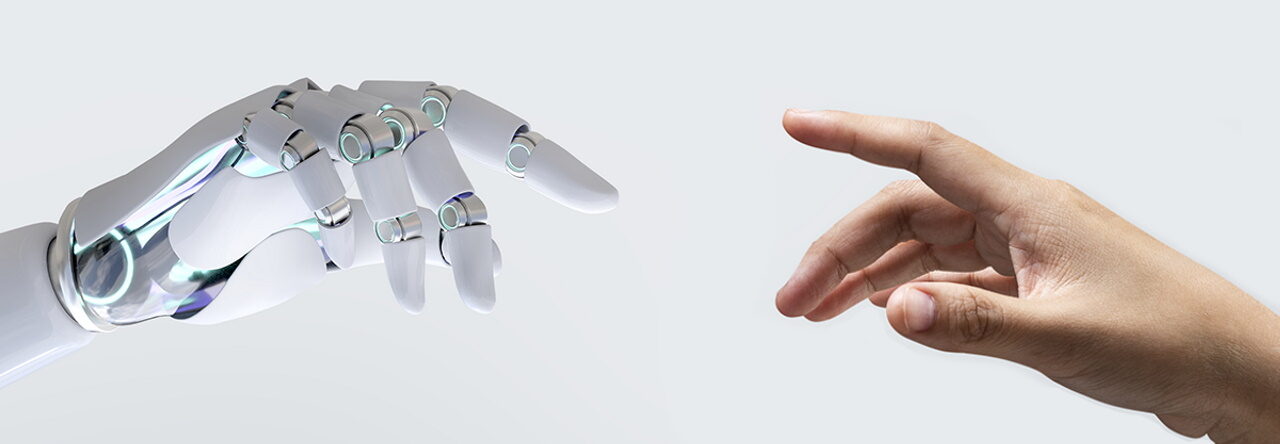Weekend Nerd
Avevo fatto pace con mia sorella entangled. Non una riconciliazione cinematografica, lacrime, abbracci e violini: un caffè amaro, parole storte, un silenzio più lungo del solito. Ma dentro qualcosa era cambiato. Un certo senso di interezza, come se un vortice nel mio campo mentale avesse smesso di lottare contro la corrente. Poi ascolto Bernardo Kastrup e tutto assume contorni più nitidi, più crudi, più veri. Non stiamo parlando di spiritualità patinata, ma di idealismo metafisico: roba da filosofi hardcore e ingegneri pentiti.
La coscienza, dice Kastrup, non è il risultato di cervelli grassi e sinapsi ispirate. È la realtà. Punto. E tutto il resto materia, spazio, tempo, sorelle incavolate è solo una rappresentazione. Non un’illusione, attenzione: un’apparenza. Il mondo, come lo percepiamo, è ciò che la mente appare essere quando la si osserva da fuori. E noi, tu, io, mia sorella e il barista che sbaglia sempre il mio ordine, siamo semplici vortici nella mente universale.
Sì, hai letto bene. Vortici. Come quei mulinelli in un fiume che sembrano entità a sé, ma sono solo movimenti dell’acqua. Ecco, noi siamo quelli. Processi dissociativi, come li chiama lui. Identità individuali tagliate fuori temporaneamente dal tutto. La morte? La fine del vortice. Il fiume resta. Sempre.
C’è qualcosa di profondamente sovversivo in questa visione. Non nel senso rivoluzionario da barbuti con manifesti, ma nel modo in cui ti scolla dalla narrativa dominante. Il materialismo è il vero dogma dei nostri tempi, non la religione. L’idea che tutto sia fisico, misurabile, quantificabile. Kastrup smonta questa convinzione con la grazia letale di uno scacchista zen. E lo fa usando la scienza stessa: esperimenti quantistici dove la realtà non si “solidifica” finché non viene osservata, studi psichedelici dove meno attività cerebrale equivale a più esperienza soggettiva. Materialismo 0, mente 1.
E allora, cos’è che resta quando smettiamo di credere che siamo macchine biologiche con un software sofisticato? Resta la responsabilità radicale. Non possiamo più dare la colpa al cervello, all’ambiente, al DNA. La sofferenza, dice Kastrup, è un dispositivo. Una funzione di sistema. Serve a reindirizzarci verso il “senso” quella parola oggi così svuotata che sembra un meme da Instagram motivazionale. Ma qui si parla di un significato non inventato, non arbitrario. Qualcosa che esiste a prescindere dalle nostre interpretazioni narcisistiche.
Ed è qui che il discorso diventa pericoloso. Perché se tutto è mente, allora ogni esperienza è reale nel senso più ontologico possibile. Anche quelle che negheremmo per comodità. L’amore, il dolore, l’invidia, la bellezza, la nostalgia per una casa che non è mai esistita: tutto è parte della mente universale che si rappresenta a sé stessa. L’idealismo metafisico, in questa lettura, non è fuga dal mondo. È assunzione totale. È smettere di fare i fighi disincantati e iniziare a guardare in faccia il fatto che la realtà è fatta della stessa sostanza dei sogni, ma con le unghie.
Non è spiritualità da centro benessere, sia chiaro. Kastrup non parla di “amore universale” o di “vibrazioni positive”. Parla di una mente che ci contiene tutti, che ci dissocia per farci vivere l’illusione dell’individualità, e che ci reintegra alla fine del ciclo. Se c’è un Dio in questa visione, è impersonale, disincantato, ma non indifferente. Un Dio come la gravità: ineluttabile, essenziale, e assolutamente non negoziabile.
A margine, c’è un dettaglio da non sottovalutare: Kastrup è un ingegnere. Uno che ha lavorato al CERN, che parlava di sistemi esperti prima che diventassero moda nei pitch degli startupper. Questo rende le sue idee ancora più fastidiose per i custodi del tempio materialista. Non è un poeta, non è un santone. È uno dei loro che si è svegliato e ha detto: “Ragazzi, vi state raccontando balle”.
E allora arrivo a mia sorella. A quel silenzio, a quel caffè. Se la mente è tutto ciò che esiste, allora ogni gesto che avviene dentro di essa anche un riconciliarsi muto è un evento cosmico. Non “grande” nel senso new age, ma reale nel modo più profondo. Perché ha trasformato un frammento di dissociazione in un momento di connessione. E se la realtà ultima è mentale, ogni riconnessione è un ritorno all’uno. Un piccolo collasso del vortice, una piega dell’acqua che si raddrizza.
Per questo ho fatto pace, non per apparire Faggin che ha visto la luce…. Non per dimenticare, non per costruire, ma per riconoscere. Che eravamo, e siamo, sempre stati parti della stessa mente. Non è un lieto fine. È una riga di codice ontologico ben scritto.
Diceva uno al bancone, tra un amarone e un Campari annacquato: “Tanto qui ci siamo tutti di passaggio, l’unica cosa reale è quando qualcuno ti guarda negli occhi e ci vedi dentro la stessa tempesta”. Ecco. L’idealismo metafisico, alla fine, è quella tempesta.
P.S. Lo diceva anche il cantante preferito di mia sorella:
Nun me scoccià’ Nun me scoccià’ Cerca di stare almeno un’ora senza parlà’ Nun me scoccià’ cchiù Tanto muore pure tu.