Questa settimana Piero Savastano ci ha fatto riflettere e ricordato che dieci anni fa Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee hanno provato a raccontarcelo con chiarezza. “The Second Machine Age” era un libro elegante, leggibile, quasi gentile nei toni. Un saggio che guardava avanti e provava a spiegarci come il mondo stesse entrando nella seconda grande rivoluzione industriale. La prima, quella che abbiamo imparato a scuola, aveva reso superflua gran parte della forza muscolare umana. La seconda, quella che stiamo vivendo adesso con un misto di euforia e panico, sta smantellando la centralità della nostra intelligenza operativa.
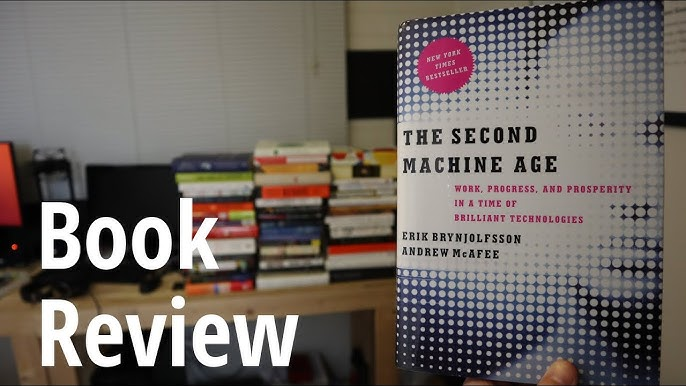
Il punto che noi condivisiamo con lui è che oggi, a distanza di un decennio, quel saggio non suona più come un’avvertenza illuminata. È diventato un diario in tempo reale.
Non si tratta più di futurologia, ma di cronaca. Quella che viviamo ogni giorno nei nostri uffici, nei flussi di lavoro digitalizzati, nei prompt lanciati su un LLM mentre ci chiediamo che senso abbia rifare per l’ennesima volta un pitch che la macchina può costruire meglio di noi. Le task cognitive che ci definivano come professionisti la sintesi, la progettazione, l’analisi, la negoziazione, persino il giudizio sono progressivamente inglobate in strutture computazionali che non si stancano, non protestano e soprattutto non sbagliano. O sbagliano, ma con stile.
Certo, possiamo chiamarla “transizione”. Un lessico da comunicato stampa, rassicurante quanto ipocrita. In verità, è un’implosione silenziosa. Un’esplosione controllata dei presupposti stessi su cui si fonda l’organizzazione del lavoro e del valore nella società postindustriale.
E non sarà né equa, né indolore.
La tecnologia non è neutra. E nemmeno democratica. Ogni innovazione significativa ha ridistribuito potere. Lo ha concentrato. Lo ha sottratto. E ora, nella seconda era delle macchine, siamo di fronte al paradosso finale: mentre aumentiamo esponenzialmente la nostra capacità produttiva, riduciamo drammaticamente la quantità di persone necessarie a generarla.
Ma cosa succede quando non serve più lavorare per vivere, ma la società continua a premiare chi lavora come se fosse ancora necessario? Quando i modelli redistributivi restano appesi a dogmi obsoleti, e chi perde il treno non ha nemmeno la stazione dove tornare?
Il rischio non è solo quello della disoccupazione tecnologica, già prevista da Keynes nel 1930, ma quello più sottile e tossico della perdita di significato. Perché l’essere umano, privato di una funzione, cerca un’identità. E quando questa non viene offerta da una narrazione condivisa e inclusiva, la si costruisce altrove: nei populismi, nei fondamentalismi, nelle nostalgie digitali di un mondo che non c’è più.
È qui che la nuova versione del luddismo trova la sua ragione d’essere. Non più uomini che distruggono telai meccanici con le mazze, ma comunità digitali che sabotano la fiducia nei sistemi. Non più fuoco alle fabbriche, ma implosione delle istituzioni. Il codice sorgente della ribellione è già scritto nei forum, nei subreddit, negli spazi grigi dove la rabbia sociale si accumula come una carica elettrostatica.
Curiosità semiseria: il movimento luddista, nel 1811, nacque non per distruggere le macchine, ma per denunciare l’uso scorretto del potere industriale contro i lavoratori qualificati. È una differenza sottile, ma essenziale. Anche oggi, non è l’IA in sé il problema. È chi la controlla, come la distribuisce, e soprattutto cosa ne fa in termini di potere negoziale.
La centralizzazione è già in atto. Le infrastrutture che sorreggono questa nuova era dalle GPU NVIDIA alle istanze LLM sulle cloud proprietarie sono proprietà privata in mano a pochissimi attori. L’oligarchia del silicio non ha bisogno di stendere cavi in tutto il mondo: ha già le chiavi della percezione, dell’interpretazione e ora, dell’azione.
Nel frattempo, le istituzioni pubbliche arrancano. Non per cattiva volontà, ma per inadeguatezza strutturale. La burocrazia è ancora modellata per un mondo analogico, lineare, lento. Il tempo legislativo non può competere con l’esponenzialità degli update software. Ed è per questo che l’asimmetria normativa diventa un moltiplicatore di rischio.
La tentazione è quella di rifugiarsi nella comfort zone della “regolazione”, come se una policy ben scritta potesse contenere un algoritmo che riscrive sé stesso ogni 72 ore. Ma la verità è più cinica: stiamo cercando di recintare l’oceano con un nastro segnaletico.
E allora? Chi può davvero fare qualcosa?
Noi, forse. O meglio: voi, noi, tutti quelli che su LinkedIn si vantano del proprio “impatto”, del “network”, delle “competenze”. Siamo in una posizione privilegiata. Non perché siamo migliori, ma perché abbiamo visto il futuro prima degli altri. E abbiamo l’obbligo morale e strategico di ridurre l’entropia, non alimentarla.
Questo non significa frenare l’innovazione. Significa guidarla. Accompagnarla con strumenti redistributivi, educazione adattiva, modelli economici nuovi che riconoscano il valore umano al di là della produttività.
Non si tratta di essere buoni. Si tratta di essere intelligenti.
Perché in un mondo dove la macchina sa già fare (quasi) tutto, l’unica cosa che non può replicare è una società che funziona. E se lasciamo che a decidere siano solo le metriche e gli shareholder, finiremo per trovarci tutti sotto un grafico con curva esponenziale e zero dignità.
La sfida non è tecnica. È etica, sociale, politica.
E il tempo per “prepararsi” è finito. Ora si gioca. Grazie Piero di averlo ricordato. (W Stregatto)
