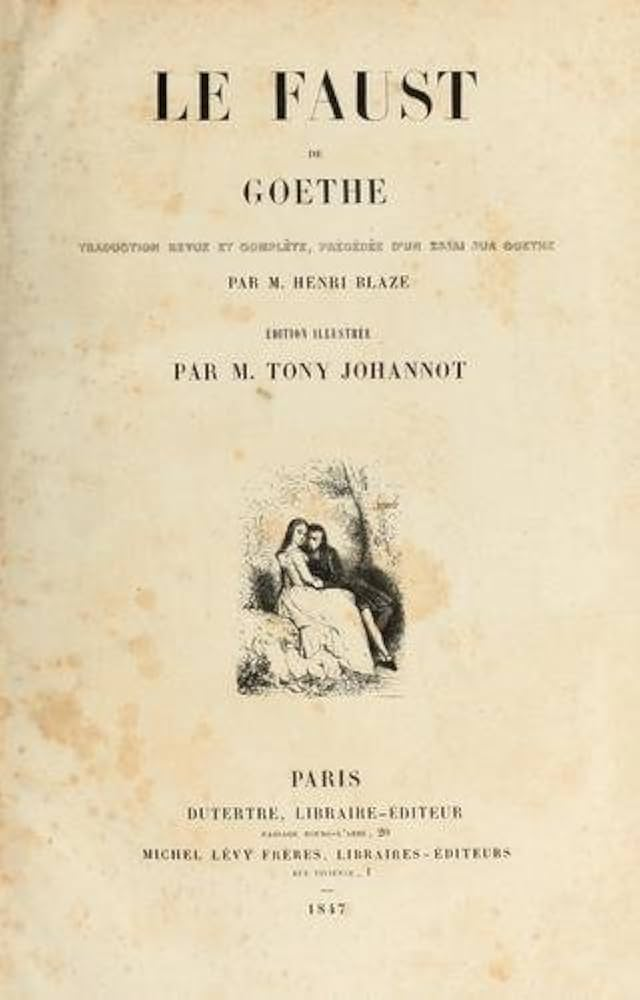C’è qualcosa di profondamente ironico nel vedere Meta, l’impero costruito da Zuckerberg sull’ossessione del “connettere il mondo”, trasformarsi nel simbolo più perfetto del patto faustiano tra potere e informazione. Cambridge Analytica non è stata solo uno scandalo, è stata la rivelazione brutale di ciò che molti sospettavano e pochi avevano il coraggio di dire: il vero prodotto non è mai stata la pubblicità, né la piattaforma sociale, ma l’essere umano stesso, venduto in blocchi di bit al miglior offerente. Non è stata una falla di sicurezza, ma una strategia tollerata, alimentata e monetizzata e qui il paradosso: la gente si scandalizzò non per l’uso dei dati, ma per la spudorata sincerità con cui quel meccanismo venne alla luce.
Meta ha patteggiato e spesso lo ha fatto più per evitare di trovarsi sul banco degli imputati che per ammettere colpe: una strategia altamente calcolata, non un ravvedimento morale.
In primo luogo, nel dicembre 2022 Meta (allora Facebook) ha accettato un accordo da 725 milioni di dollari per chiudere una class action negli Stati Uniti intentata da utenti danneggiati dallo scandalo Cambridge Analytica, senza ammettere reati.
Poi, nel 2019, era già stato pagato un’altra maxi-sanzione: 5 miliardi di dollari alla Federal Trade Commission, sempre senza ammettere alcuna responsabilità penale .
Ora arriva l’ultima puntata: secondo Reuters e AP News, il 17 luglio 2025 Meta, Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg e altri dirigenti hanno raggiunto un accordo last-minute da 8 miliardi di dollari con gli investitori intenzionati a far pagare i danni (FTC fine + cause). Un patteggiamento che ha interrotto il processo nel tribunale di Chancery in Delaware, evitando testimonianze imbarazzanti e responsabilità legali.
In nessuno di questi casi si parla di ammissione di colpa: Meta ha sistematicamente patteggiato per evitare impatti reputazionali aggiuntivi, e i dirigenti hanno evitato di testimoniare in aula.
L’accordo tra Meta e il mondo politico, rivelato dallo scandalo, ha tutti i tratti del patto del diavolo. Da un lato, i miliardi di utenti illusi di essere protagonisti di una rivoluzione digitale; dall’altro, governi, campagne elettorali e consulenti politici pronti a manipolare emozioni, paure e rabbia con chirurgica precisione psicometrica. Cambridge Analytica fu solo il nome più visibile di un fenomeno molto più esteso, una società che usava like e interazioni come strumenti di profilazione comportamentale avanzata, alimentata da un algoritmo che conosceva i desideri più intimi meglio dei diretti interessati. Chi parla di privacy violata non ha ancora capito il punto: non si è trattato di violare un diritto, ma di riscrivere la definizione stessa di libero arbitrio in chiave algoritmica.
Il genio o il demone di questa operazione stava nella sua semplicità. Bastavano poche decine di interazioni pubbliche per dedurre inclinazioni politiche, orientamenti sessuali, livello di istruzione, fragilità emotive. Un algoritmo raffinato, nutrito da dati ceduti inconsapevolmente, poteva creare messaggi iper-personalizzati per spostare l’ago della bilancia di un’elezione. Le campagne di disinformazione non erano più sparate nel mucchio, ma sparate come un cecchino direttamente nel cervello di chi era predisposto ad accoglierle. E Meta? Ha chiuso un occhio finché non è stato troppo tardi, perché ogni like e ogni commento erano denaro contante. Non c’è bisogno di immaginare una cabala segreta: bastava il cinismo tipico delle grandi corporation che vedono nei dati una risorsa naturale da estrarre, come il petrolio.
Gli effetti politici e sociali di quel patto sono ancora oggi evidenti. Le democrazie occidentali hanno scoperto che non basta un sistema elettorale solido per difendersi da un’arma invisibile capace di inoculare idee come virus. La stessa architettura di Meta, costruita per massimizzare l’engagement, è perfetta per amplificare indignazione e polarizzazione. Non è un bug, è la funzione primaria: un utente arrabbiato è un utente che scorre di più, commenta di più, clicca di più. E la rabbia, opportunamente orientata, è un’arma politica che vale più di milioni di manifesti.
Zuckerberg ha pagato multe, ha fatto pubbliche scuse, ha promesso trasparenza e nuove regole. Ma il prezzo più alto non è stato pagato da lui. Il prezzo lo stanno pagando le istituzioni che oggi faticano a recuperare credibilità, i cittadini che non distinguono più tra informazione e propaganda, e una generazione intera che ha imparato che la verità è solo questione di narrativa ben targettizzata. La vera tragedia è che il pubblico, dopo lo scandalo, ha continuato a usare le piattaforme con lo stesso fervore di prima, come tossicodipendenti che sanno perfettamente che la dose li distrugge ma non possono smettere. Questo è il trionfo del diavolo digitale: farti sapere di essere manipolato e renderti comunque complice.
Non ci si illuda che lo scandalo Cambridge Analytica sia il passato. È il modello di business di tutto l’ecosistema digitale. Meta ha semplicemente fatto da apripista, gli altri hanno preso appunti e ottimizzato le stesse tecniche. Oggi, con l’IA generativa, la capacità di creare narrazioni persuasive e credibili è infinitamente superiore, mentre i controlli etici restano praticamente inesistenti. La domanda non è più se le elezioni saranno manipolate, ma chi pagherà di più per manipolarle e con quale grado di sofisticazione.
C’è un momento, nel mito di Faust, in cui il protagonista si chiede se sia davvero possibile ritirarsi dal patto prima che sia troppo tardi. Nel caso di Meta e dell’intero capitalismo dei dati, la risposta è già scritta: non si torna indietro. I dati raccolti restano, i profili psicometrici continuano a esistere, i sistemi di targeting migliorano ogni giorno. La privacy come la conoscevamo è un concetto archeologico, utile solo per le conferenze accademiche e i manuali di diritto.
Il vero cinismo di questa storia sta nel fatto che il patto non è stato firmato solo da Zuckerberg o dai politici corrotti, ma da ognuno di noi che ha accettato di cedere la propria attenzione in cambio di un briciolo di gratificazione sociale digitale. Abbiamo barattato consapevolmente il controllo delle nostre emozioni per qualche notifica e un pollice alzato. Meta e Cambridge Analytica non hanno fatto altro che sfruttare questa debolezza universale. E il diavolo, come sempre, si nutre di ciò che gli offriamo volontariamente.