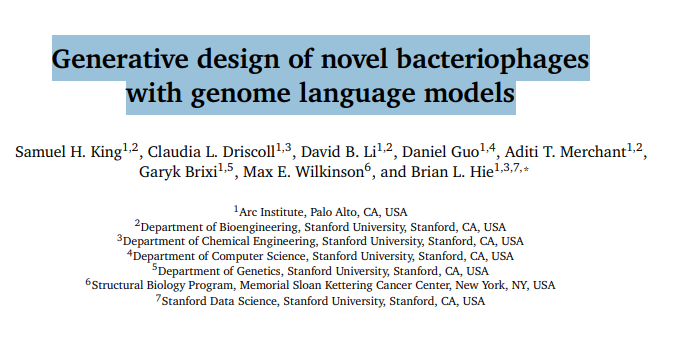Generative design of novel bacteriophages
with genome language models
La notizia che un algoritmo abbia scritto un virus funzionante è servita come antipasto mediatico, ma il piatto forte è arrivato più silenzioso da Stanford e Arc Institute, dove un gruppo di ricercatori ha fatto qualcosa che somiglia a un atto di creazione: intelligenza artificiale genetica capace di progettare interi genomi viventi. Non mutazioni di laboratorio, non copie digitali, ma sedici batteriofagi sintetici costruiti da zero, testati in vitro, in grado di replicarsi, di evolversi e persino di superare in efficienza l’antenato naturale da cui sono partiti.
Il dettaglio che fa tremare i polsi è che tutto questo è stato ottenuto con modelli linguistici non molto diversi da quelli che oggi generano testi o immagini, con la differenza che qui il vocabolario non è fatto di parole ma di miliardi di basi azotate. La sintesi di genomi artificiali che fino a ieri sembrava materia da fantascienza è stata ridotta a problema computazionale. Le macchine hanno imparato la grammatica della vita e non si sono limitate a coniugare qualche verbo, hanno scritto un romanzo intero e l’hanno fatto respirare.
Molti si sono soffermati sulla percentuale di successo. Dei 302 genomi inventati, solo sedici hanno preso vita. Ma chi conosce la biologia sa che la natura stessa si basa su un tasso di fallimento infinitamente più alto. Che sedici strutture create dal nulla possano infettare E. coli e in alcuni casi battere la versione wild-type è già un risultato che ribalta lo status quo della biologia sintetica. Non è un caso se alcuni commentatori parlano di un traguardo paragonabile a quello di Craig Venter con la cellula minimale del 2010, ma in versione accelerata e automatizzata.
Il vero punto, però, non è la tecnica in sé, ma ciò che essa apre. L’uso di intelligenza artificiale genetica per progettare batteriofagi è già stato messo alla prova in un cocktail capace di superare la resistenza batterica che bloccava i fagi naturali. In un mondo in cui gli antibiotici stanno diventando monete fuori corso, l’idea di progettare terapie su misura non è più un sogno ma un’ipotesi concreta. Oggi si parla di infezioni resistenti, domani si parlerà di soluzioni personalizzate, cucite come software. Una medicina fatta di linee di codice che diventano organismi, capace di intervenire là dove l’evoluzione naturale era lenta o cieca.
Il potenziale non si ferma alla medicina. Una volta che l’AI impara la sintassi dei genomi, la stessa logica può essere usata per modellare microbi industriali che producono composti chimici sostenibili, oppure virus che modulano i microbiomi in agricoltura e acquacoltura. Persino vettori virali per trasportare farmaci o materiali dentro i tessuti umani possono essere ripensati come strumenti progettati con la stessa disinvoltura con cui un ingegnere software compila un programma. La sintesi di genomi artificiali diventa una piattaforma tecnologica, non un esperimento isolato.
Chi si entusiasma dimentica il lato oscuro. È proprio qui che la questione etica scivola da dibattito accademico a necessità urgente. Non parliamo di scenari apocalittici da Hollywood, ma del fatto che la linea tra ciò che possiamo fare e ciò che dovremmo fare si sta assottigliando a una velocità che i regolatori non possono più ignorare. Se un algoritmo può scrivere genomi interi, allora la biologia diventa software. E quando la biologia è software, l’hacking non è più una metafora ma una possibilità concreta.
I ricercatori hanno adottato cautele, hanno limitato i modelli a famiglie virali non patogene, hanno filtrato sequenze umane, hanno lavorato in ambienti certificati. Tutto corretto. Ma l’esperimento dimostra che il confine tecnico è stato superato. Restano solo barriere normative e morali, notoriamente più fragili del silicio. La biologia sintetica non è più confinata a laboratori iper-specializzati, è entrata nel dominio dei modelli generativi, e chiunque segua l’evoluzione delle AI sa che la traiettoria è sempre verso l’accessibilità.
Qualcuno ha osservato con ironia che i modelli hanno prodotto errori, molti genomi erano non funzionanti. Eppure persino i successi hanno mostrato tratti imprevisti, come il rimpiazzo di un gene strutturale che si pensava indispensabile. Qui sta la vera rivelazione. Le macchine non solo riproducono ciò che sappiamo, ma trovano scorciatoie evolutive che non avevamo mai immaginato. È l’equivalente biologico di una mossa di scacchi che nessun maestro umano avrebbe concepito. Innovazione e rischio, mescolati nella stessa imprevedibilità.
Il dato più provocatorio è la velocità con cui siamo passati da algoritmi che scrivono testi a modelli che scrivono organismi. Meno di dieci anni per passare dal saggio scolastico alla cellula sintetica. In questo ritmo accelerato, la società si trova a inseguire, a correre dietro a tecnologie che inventano mondi prima ancora che possiamo regolamentarli. L’intelligenza artificiale genetica non si limita a predire la biologia, la reinventa. Il laboratorio diventa estensione del data center.
Nella narrativa pubblica si parla spesso di AI come di un assistente digitale che scrive mail o ottimizza ricerche. Ma la verità è che la stessa logica matematica, applicata alle sequenze biologiche, sta spostando il confine della creazione. Non siamo più semplici osservatori dell’evoluzione, stiamo diventando coautori. Che questa co-scrittura sia la salvezza contro pandemie e resistenze batteriche, o la porta aperta a nuove minacce, dipende meno dalla tecnologia e più dalla governance che sapremo costruire.
La domanda che rimane sospesa è se siamo pronti. La biologia sintetica generativa non aspetta i tempi lenti della burocrazia, e il mercato fiuta già l’odore di un’industria intera da plasmare. Phage therapy, microbiomi programmati, organismi ingegnerizzati per bonificare ambienti o produrre energia: ogni campo può diventare terreno fertile per chi avrà il coraggio e l’incoscienza di scrivere codice genetico con la stessa disinvoltura con cui oggi si lancia una startup SaaS. La differenza è che qui non si gioca con software, ma con materia vivente.
Non sorprende che la paura sia cresciuta. I sondaggi mostrano che la popolazione percepisce sempre più l’AI come minaccia alla propria identità umana, anche quando ne riconosce i benefici quotidiani. È un paradosso moderno: vogliamo che l’intelligenza artificiale semplifichi le nostre vite, ma temiamo che semplifichi troppo la definizione stessa di cosa significhi essere vivi. In questo caso la paura non è paranoia, è semplice lucidità. Perché se l’AI può scrivere un genoma, allora può anche scrivere un errore. E in biologia gli errori non finiscono nel cestino, si replicano.
Quello che oggi sembra un’anteprima scientifica sarà ricordato domani come punto di non ritorno. La sintesi di genomi artificiali tramite modelli linguistici è già un fatto compiuto. La retorica dell’innovazione “responsabile” non basta più, serve un pensiero sistemico che affronti la realtà: stiamo scrivendo evoluzione in tempo reale. La tecnologia non chiede permesso, e l’etica non corre mai abbastanza veloce. Chi governa dovrà decidere se trattare questi strumenti come il più grande alleato della medicina moderna o come la pistola carica lasciata sul tavolo di una civiltà che non smette di giocherellare con il grilletto.
Paper: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.09.12.675911v1