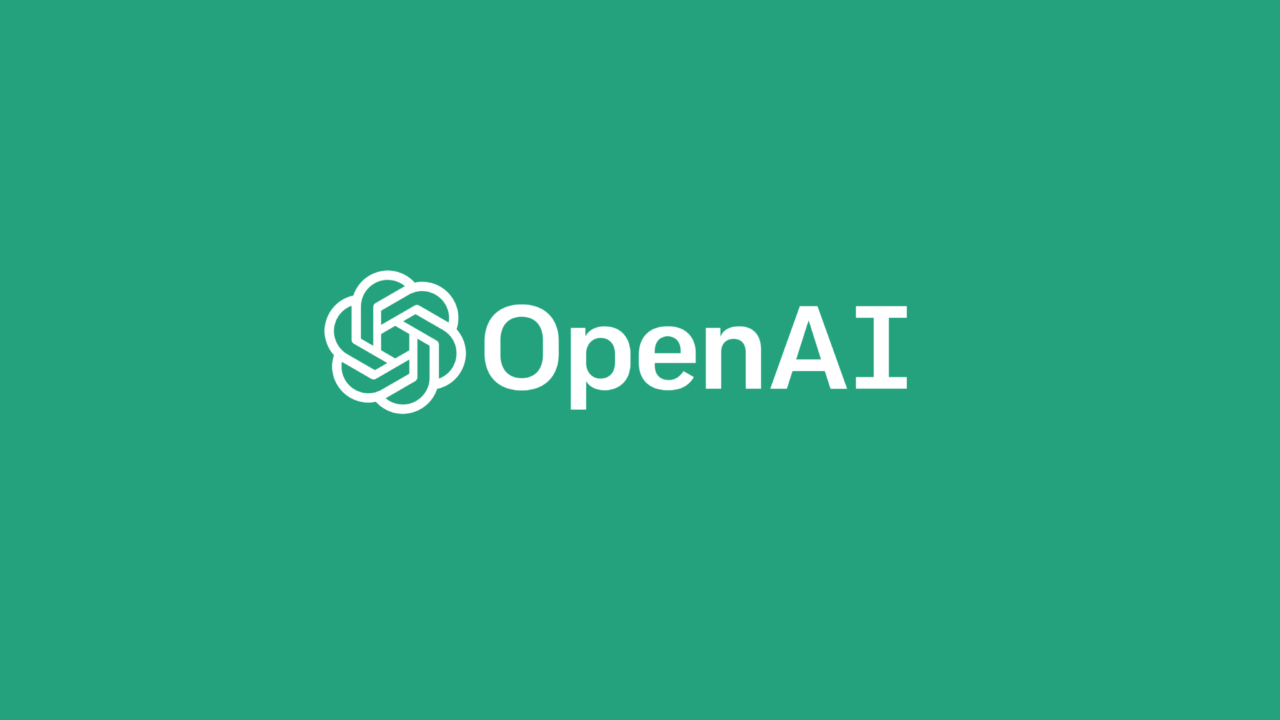Ne abbiamo parlato su PREMIUM Rivista.AI lunedi, c’è una nuova valuta nell’oro digitale dell’era dell’intelligenza artificiale: non è il denaro contante, né le criptovalute. È l’equity. Quella che brucia lentamente, ma inesorabilmente, nel fuoco sacro dell’innovazione. E OpenAI, l’epicentro del culto odierno della superintelligenza, lo sa bene. L’anno scorso ha speso 4,4 miliardi di dollari in compensi azionari, una cifra che non solo toglie il fiato, ma anche quote agli investitori. È come pagare l’affitto del talento con la casa stessa. E la casa, signori, è vostra.
Il punto non è il denaro, è il potere. O meglio, il potere diluito. Quando un’azienda emette azioni per pagare i propri dipendenti, in particolare quelli di fascia altissima come i ricercatori AI che oggi valgono come interi team, sta vendendo futuro in cambio di presente. E in Silicon Valley questa è prassi, ma con l’intelligenza artificiale il gioco è diventato iperbolico. In un settore in cui ogni ingegnere può spostare la frontiera tecnologica, ogni punto percentuale di equity diventa una moneta da guerra. “Un top researcher? Serve l’1% del capitale. Subito”, mi ha detto un investitore che gioca nel campionato delle seed round AI. In altre parole, si tratta di vendere l’anima per un LLM.
Tradizionalmente, gli investitori tollerano una diluizione del 2-4% l’anno legata ai piani di compensazione in azioni. È il pedaggio per scalare. Ma le startup AI, guidate da una domanda di talento insaziabile, superano tranquillamente questa soglia. E non lo fanno per leggerezza. È la logica del panico tecnologico: se non lo prendi tu, lo prende Meta. E Meta non lesina. Sta convertendo le sue bacheche social in centrali AI e compra tutto ciò che respira e conosce TensorFlow. Così OpenAI è costretta a rincorrere, alzare, promettere. Più opzioni, più equity, più diluizione.
È il classico esempio in cui la traiettoria di crescita giustifica gli sprechi apparenti. Prendiamo Databricks: ha aumentato il numero di azioni emesse di meno del 5% nell’ultimo esercizio, ma ha visto la propria valutazione esplodere del 44%, toccando i 62 miliardi di dollari. Sembra un affare onesto. OpenAI, invece, ha fatto di più e di peggio: nel 2023 ha moltiplicato per cinque i propri compensi azionari rispetto all’anno precedente, in un contesto in cui la sua valutazione (presunta) ha toccato i 300 miliardi di dollari. Il mercato sembra dire: ok, va bene così. Almeno per ora.
Il paradosso è che questo modello si basa su una scommessa piramidale. Finché il valore percepito sale più velocemente della diluizione reale, gli investitori sorridono. Ma se la crescita si arresta, anche solo per un trimestre, la piramide inizia a tremare. A quel punto, quei pacchetti di stock option da capogiro diventano bombe a orologeria sul bilancio e sulle aspettative. Non è un problema di flusso di cassa – non ancora, almeno – perché fino alla quotazione le stock option non intaccano il cash. È un problema di governance, di fiducia, di visibilità sul ROI futuro.
In un certo senso, l’AI ha riportato in auge una forma estrema di “capitalismo dei founder”, dove i grandi cervelli sono diventati i nuovi asset critici. Non parliamo di CTO o VP Engineering, ma di profili specifici, ibridi tra matematico e stregone, capaci di addestrare modelli transformer come se stessero componendo sinfonie quantistiche. In questa nuova gerarchia del valore, un algoritmo addestrato bene può valere più di una linea di business. E per trattenerlo, bisogna pagare. Non in contanti, ma con equity. Perché la liquidità rende infedeli, mentre la partecipazione azionaria lega a doppio filo.
Certo, l’illusione regge finché i numeri crescono. Finché i finanziamenti arrivano. Finché l’interesse di mercato supera il peso specifico delle quote. Ma la domanda che aleggia tra gli LP (limited partners) è se questo schema sia sostenibile. Perché a furia di pagare le star dell’AI in quote, si rischia che gli investitori tradizionali – quelli che mettono i soldi veri – si ritrovino soci di minoranza in aziende che hanno solo promesse e parametri proxy di revenue.
OpenAI, poi, è un caso unico. Formalmente non è nemmeno una vera tech company. È una strana creatura a metà tra non-profit, laboratorio e veicolo commerciale. La sua struttura ibrida permette flessibilità estrema ma genera anche opacità nei bilanci. Come si valuta davvero un’azienda il cui core business è una tecnologia in divenire, venduta a peso di hype e royalties future? E quanto pesa, in questo contesto, un pacchetto azionario dato oggi a un ricercatore che domani potrebbe andare a costruire un AGI?
Si racconta che in certe board room si discuta già della “equity inflation” nel settore AI, un fenomeno che potrebbe rendere l’intera architettura delle startup fragile come un castello di sabbia. Troppi titoli, troppo velocemente, per troppo pochi risultati tangibili. Eppure, gli stessi investitori non smettono di finanziare il sistema, anche a costo di farsi diluire. Perché? Perché fuori c’è il deserto. Perché ogni nuova OpenAI potrebbe essere quella buona. Perché la paura di restare esclusi è più forte del timore di venire tagliati fuori dalla cap table.
La verità, poco raccontata, è che l’AI non è solo una rivoluzione tecnologica. È una rivoluzione contabile. Dove il capitale umano è trattato come intangibile, ma prezzato come se fosse liquido. Dove la visione del founder vale più di un piano quinquennale. Dove si preferisce assumere al massimo delle opzioni, piuttosto che perdere anche solo una settimana di vantaggio computazionale. È una bolla? Forse. Ma è una bolla razionale, alimentata dalla scarsità vera di talento e dalla narrativa potente del cambiamento radicale.
E così, mentre OpenAI moltiplica il proprio equity spending e si prepara a raccogliere altri 40 miliardi, gli investitori si consolano con la valutazione. 300 miliardi. È il mantra. È l’ancora. È la foglia di fico che giustifica ogni concessione azionaria. Finché il numero cresce, tutto è perdonato. Ma il giorno in cui la curva si piegherà – e accadrà, come sempre – scopriremo se davvero valeva la pena vendere il 119% del proprio fatturato in stock option. E se l’intelligenza artificiale può davvero giustificare una tale dispersione del valore azionario, o se abbiamo semplicemente costruito il futuro su una diluizione ben narrata.