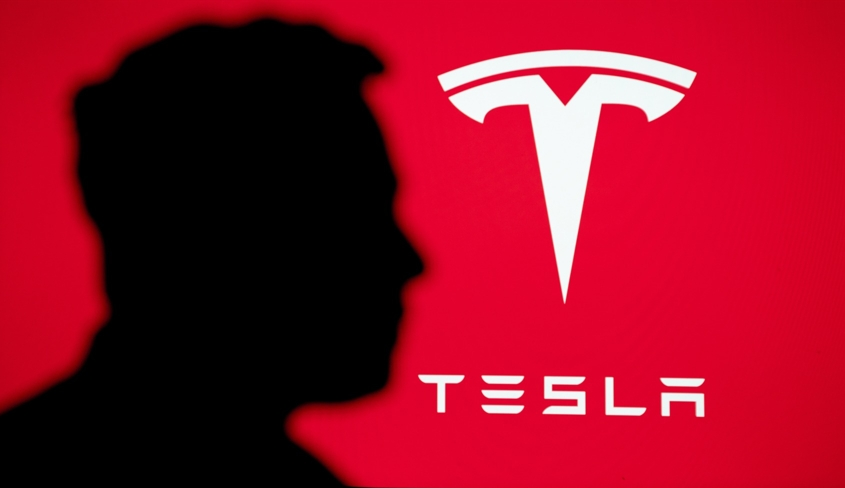Se vi dicessero che per trattenere un CEO serve un bonus da 23,7 miliardi di dollari, vi verrebbe da ridere o da vendere immediatamente le vostre azioni? Benvenuti nell’universo di Tesla, dove l’iperbole è regola e la governance aziendale un esercizio di prestidigitazione. Il consiglio di amministrazione, con una serenità degna di un Politburo, ha dichiarato che l’assegnazione monstre a Elon Musk è solo “un primo passo fondamentale” per tenerlo concentrato sull’azienda. Già, perché 23,7 miliardi sono solo un assaggio, un’apericena azionaria. Il vero piatto forte è ancora in tribunale.
Il pacchetto retributivo originale da 56 miliardi di dollari, approvato nel 2018 e poi cassato da un giudice del Delaware con la stessa freddezza con cui si respinge una mozione irricevibile, è ancora oggetto di contesa. E nel frattempo si fa strada questa nuova ondata di stock option, benedetta dal board con l’aria di chi non ha scelta. Il messaggio è chiaro: o Elon resta, oppure Tesla perde la sua scintilla. Una tesi discutibile, ma utile a legittimare una concentrazione di potere che sfiora il culto della personalità.
Musk, che oggi detiene circa il 13% della società, ha dichiarato più volte di voler salire almeno al 25%, soglia magica che gli garantirebbe un controllo quasi assoluto pur restando formalmente in minoranza. Le nuove 96 milioni di azioni, che potrà reclamare a condizione di mantenere un “ruolo di leadership senior” per i prossimi due anni, valgono grosso modo il 3% del capitale. Se si sommano al suo attuale pacchetto, siamo sulla buona strada. Ma attenzione: non si tratta solo di soldi. Si tratta di controllo, influenza, centralità strategica. Il solito Elon, affamato non di stipendi, ma di imperi.
Gli azionisti, secondo quanto dichiarato dal consiglio, “hanno espresso preoccupazione per la necessità di mantenere le energie di Elon concentrate su Tesla”. Un’eufemismo elegante per dire che Musk è diventato una sorta di CEO quantistico: simultaneamente presente su X, SpaceX, Neuralink, Starlink, e in qualche modo anche in aula a difendere pacchetti retributivi fuori scala. Il rischio, per Tesla, è quello di essere solo uno dei tanti giocattoli nella cassapanca del magnate. Il consiglio lo sa, e gioca la carta della ricompensa come deterrente.
Dal punto di vista del mercato, il segnale è ambivalente. Da un lato, lunedì le azioni Tesla sono salite del 2%, arrivando a 309,44 dollari. Un riflesso pavloviano che segue ogni volta che il nome di Musk viene associato a Tesla con un contratto più lungo di un tweet. Dall’altro lato, però, la prospettiva di una governance modellata su un unico individuo — e per di più, uno notoriamente imprevedibile — solleva interrogativi sulla sostenibilità a lungo termine dell’intero progetto. Chi guida davvero Tesla? Il consiglio? Gli azionisti? O l’uomo che twitta dal jet privato?
L’assegnazione a 23,34 dollari per azione è di fatto una chiamata in stile venture capital: se Tesla continuerà a crescere, Musk realizzerà un guadagno stellare. Se invece l’azienda dovesse inciampare, il pacchetto diventerà carta straccia. In teoria, un incentivo meritocratico. In pratica, un modo per blindare Musk senza dargli ufficialmente una golden share. E mentre il Delaware riflette sull’equità del vecchio piano da 56 miliardi, questo nuovo pacchetto si presenta come una polizza di assicurazione narrativa: se perdiamo il vecchio schema, almeno ne abbiamo uno nuovo pronto all’uso.
È difficile non notare una certa ironia in tutto questo. In un’epoca in cui la Silicon Valley si riempie la bocca di governance etica, ESG e responsabilità sociale, Tesla torna alle origini: fondatore carismatico, compensi sproporzionati, struttura di potere fortemente accentrata. Come una startup che si rifiuta di crescere davvero, nonostante la capitalizzazione da multinazionale. La differenza è che, oggi, Tesla non è più solo un’azienda automobilistica. È un simbolo, un marchio identitario, un catalizzatore di fede. E come ogni fede, non tollera l’ambiguità.
Il punto cieco di questa narrativa? Il fatto che ogni pacchetto retributivo, per quanto colossale, poggia su una premessa fragile: che Musk sia insostituibile. Una premessa affascinante, certo, ma pericolosa. Se domani decidesse di concentrare tutte le sue energie su una colonia su Marte, Tesla diventerebbe un’auto senza pilota. E non parliamo di software. L’azienda ha strutture, ingegneri, supply chain, un marchio globale. Ma tutto ciò sembra ruotare intorno all’umore e agli interessi di un uomo solo. Un uomo che, nel frattempo, flirta con l’idea di fondare la sua intelligenza artificiale e gestire il flusso informativo planetario via Starlink.
Per i detrattori, questo nuovo piano è la prova definitiva che Tesla non è più governata da un board indipendente, ma da una corte che ruota attorno al suo sovrano. Per i fan, è l’ennesima conferma del genio visionario che si merita tutto ciò che ottiene. La verità, come sempre, sta nel mezzo. Ma l’impressione è che la bilancia stia pendendo pericolosamente verso il culto del fondatore. E chi conosce la storia del business sa che nessun impero sopravvive a lungo senza successione.
La questione vera, che nessuno alza con forza nei salotti finanziari, è se questo modello sia replicabile. Può un’azienda da mille miliardi essere strutturata come una monarchia? È sano dipendere da una sola mente, per quanto brillante? La risposta la daranno i prossimi trimestri. E forse anche le aule di tribunale. Nel frattempo, Musk incassa, Tesla galleggia, e il consiglio finge di avere il timone. Ma come in ogni favola moderna, resta il dubbio: l’imperatore ha davvero gli abiti addosso, o stiamo tutti fingendo di non vedere?