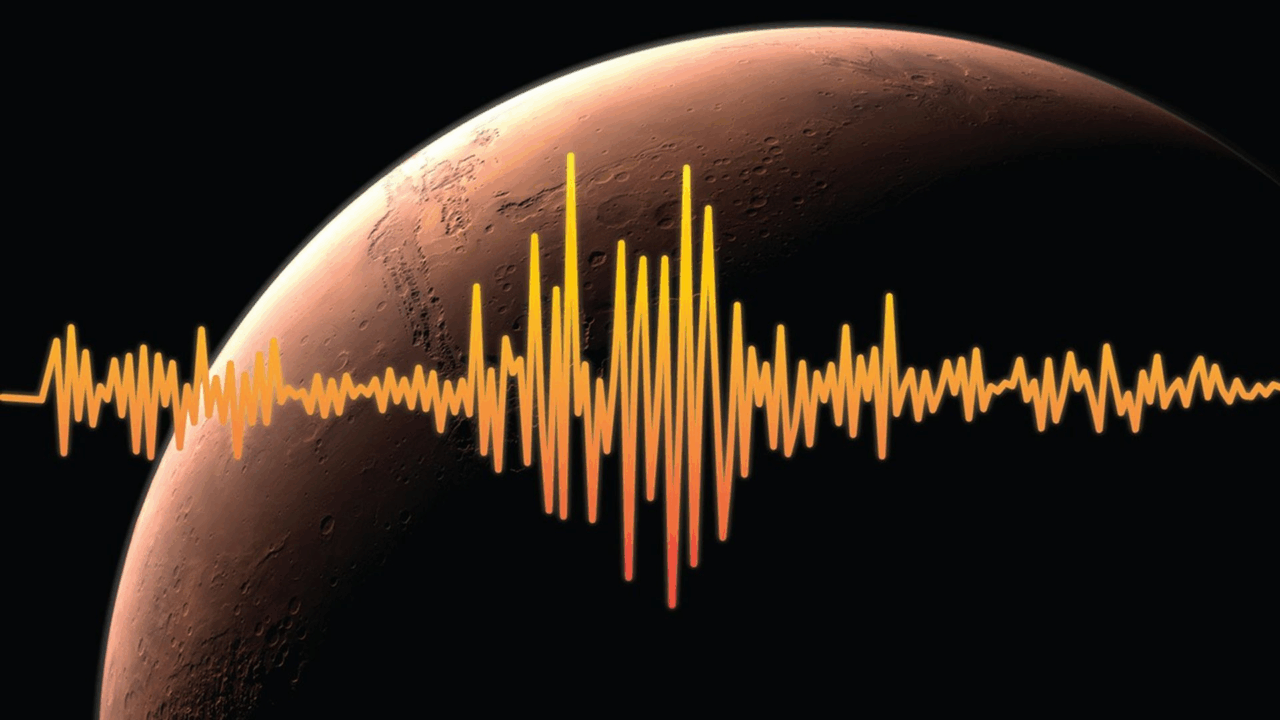Il concetto di “medicina di prossimità” assume un significato completamente diverso quando il paziente è a 384.400 chilometri dalla farmacia più vicina e il medico di guardia è un’intelligenza artificiale. Fino ad oggi, gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale hanno potuto contare su un filo diretto con Houston, rifornimenti regolari di farmaci e strumenti, e persino un passaggio di ritorno in poche ore in caso di emergenza grave. Ma tutto questo sta per diventare un lusso del passato. Con la NASA che, insieme a partner commerciali come SpaceX di Elon Musk, punta a missioni di lunga durata verso la Luna e Marte, il paradigma della cura medica in orbita sta cambiando in modo irreversibile.
La questione non è se ma come garantire assistenza sanitaria in un contesto in cui la velocità della luce diventa un collo di bottiglia per le comunicazioni e dove la logistica medica si misura in mesi, non in giorni. Il mantra interno della NASA, “Earth-independent medical care”, è ormai più di uno slogan: è una strategia di sopravvivenza. Qui entra in scena un progetto che sembra uscito da un incrocio tra “2001: Odissea nello Spazio” e un manuale di pronto soccorso: il Crew Medical Officer Digital Assistant, o CMO-DA, sviluppato da NASA in collaborazione con Google, e incubato nella piattaforma Vertex AI del colosso di Mountain View.
Secondo David Cruley, customer engineer della divisione Public Sector di Google, “l’applicazione è progettata per guidare l’astronauta attraverso la diagnosi e il trattamento anche in condizioni di totale blackout comunicativo”. La multimodalità non è un optional: voce, testo e immagini convivono nello stesso ambiente operativo, riducendo il margine di errore in scenari in cui ogni minuto può fare la differenza. L’accordo con Google è a prezzo fisso e include infrastruttura, servizi cloud e addestramento dei modelli, ma il codice sorgente resta di proprietà NASA, che lo ha già ottimizzato per le esigenze della medicina spaziale.
Tre scenari clinici hanno fatto da banco di prova: dolore alla caviglia, dolore al fianco e dolore all’orecchio. Una triade apparentemente banale per la medicina terrestre, ma che in microgravità può nascondere insidie impreviste. Un team composto da tre medici, tra cui un astronauta con esperienza di missione, ha valutato l’accuratezza diagnostica e la qualità del piano terapeutico del CMO-DA. I risultati? 88% di probabilità di correttezza per la caviglia, 80% per l’orecchio, 74% per il fianco. Percentuali che farebbero invidia a molti medici di pronto soccorso nelle metropoli terrestri.
Il piano di sviluppo non è un salto nel vuoto ma un approccio incrementale. Nei prossimi aggiornamenti, il sistema sarà integrato con sensori e dispositivi medici, e addestrato a riconoscere condizioni specifiche dello spazio, come i cambiamenti fisiologici indotti dalla microgravità o gli effetti delle radiazioni cosmiche. La NASA parla di “situational awareness”, un concetto che nella medicina terrestre suona quasi poetico ma che, in orbita, è sinonimo di vita o morte.
È qui che l’analisi si fa interessante. Una volta validato in orbita, un sistema simile potrebbe trasformare radicalmente la medicina di emergenza in aree remote della Terra, dove la carenza di medici è cronica e i tempi di intervento lunghi. Cruley non conferma se Google stia già pensando a una certificazione regolatoria per uso terrestre, ma lascia intendere che l’opzione è sul tavolo. Il vero valore strategico non sta solo nell’aiutare un astronauta a curarsi su Marte, ma nel trasferire quel know-how sulla Terra, moltiplicando l’impatto della ricerca spaziale sull’economia e sulla sanità globale.
Il parallelo storico è inevitabile: la tecnologia sviluppata per le missioni Apollo ha generato intere industrie, dai sistemi di filtraggio dell’acqua ai materiali compositi per l’aerospazio civile. Ora potremmo trovarci di fronte a una nuova generazione di “spinoff tecnologici” in ambito medico. È la logica stessa dell’innovazione spaziale: investire per un contesto estremo e poi applicare su larga scala ciò che ha superato la prova più dura.
La domanda che resta sospesa è se siamo pronti ad affidare la nostra salute, e quella di chi vive e lavora a milioni di chilometri dalla Terra, a un assistente digitale. Chi conosce la storia dell’esplorazione spaziale sa che la risposta, alla fine, non la daranno le statistiche ma il primo astronauta che, grazie a un algoritmo, sopravviverà a un’emergenza medica su Marte. E quando accadrà, quella “prima volta” diventerà un caso di studio nelle università e nelle sale riunioni delle multinazionali della sanità. In fondo, come diceva Arthur C. Clarke, “ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia”. In questo caso, la magia avrà il volto di un’interfaccia su schermo fluttuante in una cabina pressurizzata a milioni di chilometri da casa.