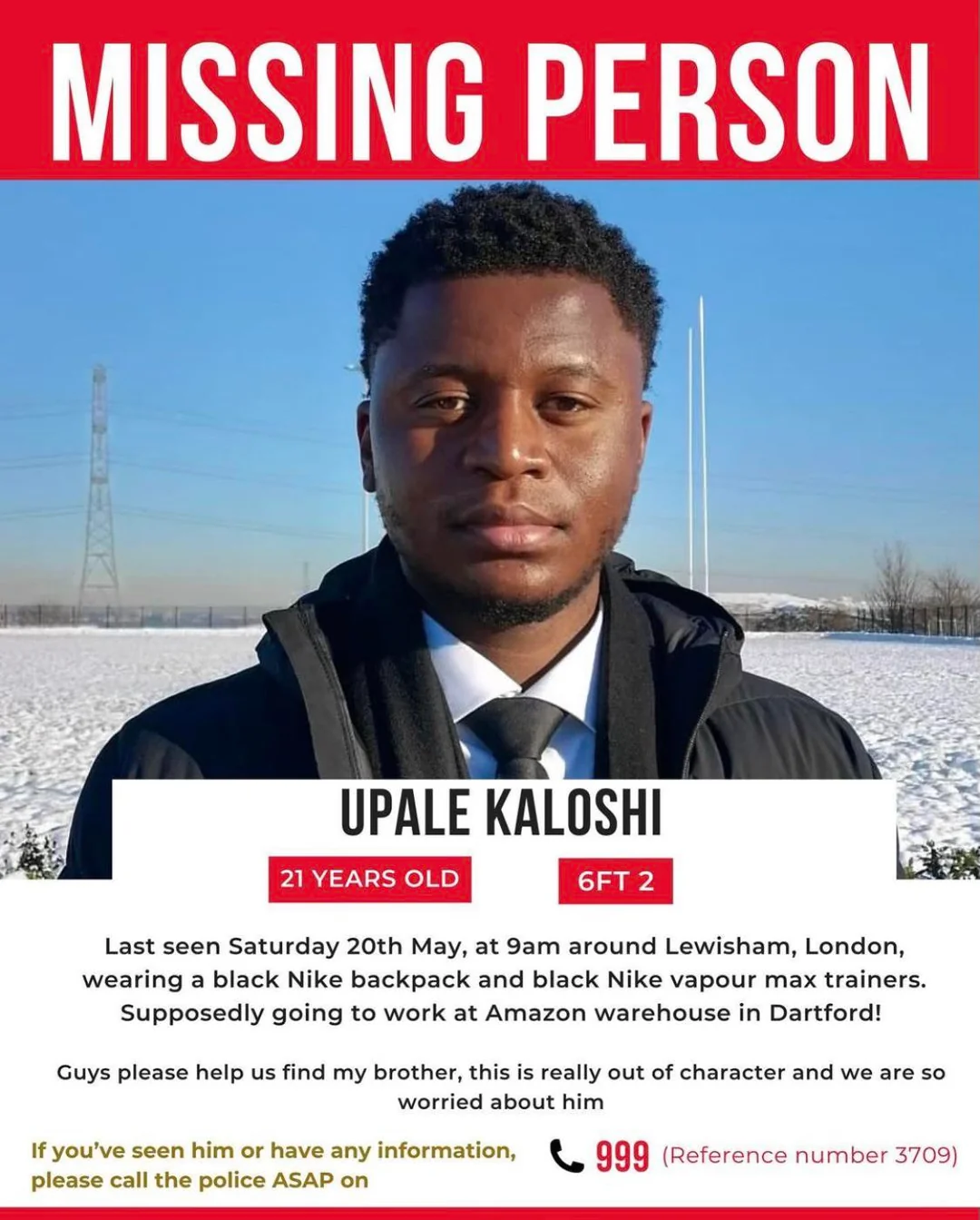Ci sono domande che pesano come macigni: dove finiscono le persone che scompaiono nel nulla? Non parliamo di romanzi gialli, ma di migliaia di vite dissolte in guerre civili, narcotraffico, regimi autoritari e persino nelle pieghe della nostra società iperconnessa. Jorge Ruiz Reyes dell’Università di Oxford, Derek Congram della Simon Fraser University, Renée A. Sirbu del Digital Ethics Center di Yale e Luciano Floridi, il filosofo digitale oggi a Bologna, hanno pubblicato una ricerca che, senza mezzi termini, cambia le regole del gioco. Hanno coniato un nome elegante, “data-based disappearance analysis”, che tradotto suona come: proviamo a usare le macchine per scoprire dove i corpi spariscono e chi li ha fatti sparire. Un mix di statistica, geografia computazionale e intelligenza artificiale che promette di rivoluzionare un campo dove troppo spesso l’unico metodo è la pala e la testimonianza disperata di un familiare.
Quello che emerge è spiazzante. Negli anni ’90 gli analisti contavano i morti come si contano le pecore: con registri incompleti e bias evidenti. Oggi, grazie a tecniche come il Multiple Systems Estimation, si può stimare quanti desaparecidos non sono mai stati registrati. La matematica diventa un’arma politica perché i numeri costringono gli stati a riconoscere la portata dei crimini. E se vi sembra accademia, basti pensare che queste tecniche hanno ricostruito il numero delle vittime in Guatemala, ex Jugoslavia e Colombia, ribaltando la narrazione ufficiale.
La seconda arma è la geografia digitale. Congram ha dimostrato che i ribelli spagnoli negli anni ’30 non seppellivano i corpi a caso: c’erano pattern spaziali, logiche ambientali, addirittura un “design criminale” nella scelta dei luoghi. Con immagini satellitari e modelli di entropia massima, oggi si possono individuare aree probabili di fosse comuni in Messico o in Etiopia. In altre parole, Google Earth non serve solo per spiare la villa del vicino, ma per inchiodare regimi e cartelli che credevano di nascondere i cadaveri sottoterra.
Poi arriva l’intelligenza artificiale, il giocattolo più discusso del momento. Algoritmi capaci di prevedere se un anziano disperso in Colombia sarà ritrovato vivo, reti complesse per mappare centri di detenzione clandestini in Argentina, modelli multimodali negli Stati Uniti che analizzano foto e video per riconoscere persone scomparse. Non siamo più nella fantascienza, ma in un campo etico minato. Perché se i dati aiutano a cercare i dispersi, possono anche essere usati per sorvegliare, manipolare, silenziare chi indaga. Lo stesso strumento che localizza una fossa comune può servire a uno Stato per schedare oppositori politici. Floridi e Sirbu non lo nascondono: senza governance e regole etiche, la DDA rischia di diventare l’ennesima distopia digitale.
Il punto è che le famiglie delle vittime non hanno tempo per i convegni sulla privacy. Vogliono risposte. Vogliono sapere se il figlio finito nelle mani dei narcos è in una cella o in una fossa. Qui entra in gioco la vera tensione: tra la lentezza delle istituzioni, che parlano di diritti umani, e la velocità delle AI, che macinano dati in tempo reale. La tecnologia non sostituisce la pala, ma indica dove scavare. E, dettaglio non secondario, toglie agli stati la possibilità di fingere che non ci sia nulla da trovare.
Questo nuovo approccio, il data-based disappearance analysis, non è un semplice aggiornamento metodologico. È un atto politico. È la prova che l’infosfera può fare giustizia dove tribunali e governi falliscono. Certo, servono dataset, trasparenza, cooperazione internazionale. Ma la direzione è chiara: i desaparecidos non sono più invisibili. E la domanda non è più “dove sono finiti?”, ma “quanto a lungo gli stati potranno fingere di non vederli?”.
Where are they? A review of statistical techniques and data analysis to support the search for missing persons and the new field of data-based disappearance analysis
lJorge Ruiz Reyes
Derek Congram
Renée A. Sirbu
Luciano Floridi