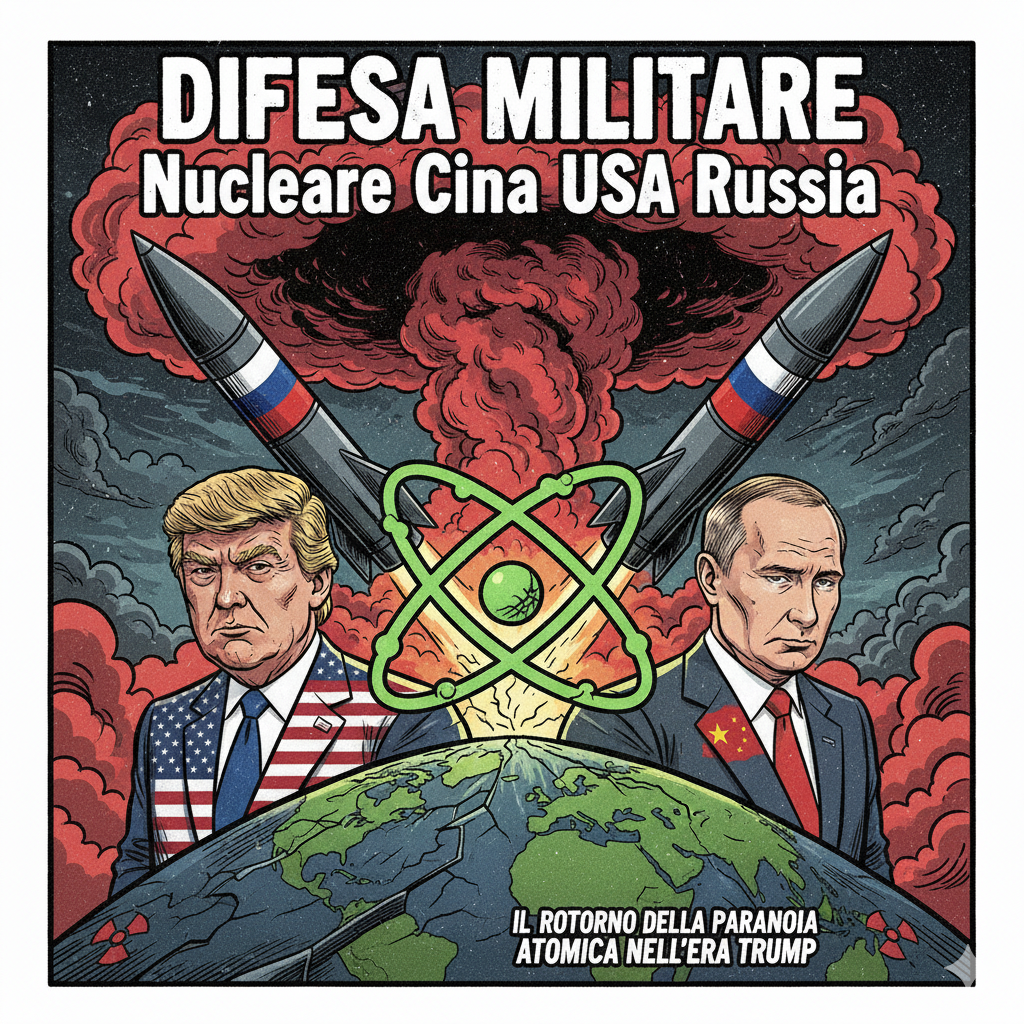Trump non è mai stato un campione della coerenza strategica, ma il vertice di Anchorage con Putin ha confermato un fatto elementare che nessuno a Washington o Mosca osa più dire ad alta voce: la stagione del controllo degli armamenti è finita, quella della paranoia atomica è tornata.
Il tentativo goffo di trascinare Pechino dentro una cornice trilaterale di “denuclearizzazione” ha avuto l’effetto opposto. La Cina ha alzato le spalle e ricordato con tono glaciale che il proprio arsenale, ancora modesto se confrontato con quello americano o russo, non merita affatto di essere discusso sullo stesso piano. Non è una questione di numeri, è una questione di percezione geopolitica. Xi Jinping non ha alcun interesse a trasformare il suo status di outsider nucleare in quello di comprimario in un teatro dominato dagli eredi della Guerra fredda.
Il problema è che i numeri iniziano a correre più veloce della diplomazia. Le stime SIPRI indicano una Cina che passa da circa 500 testate nel 2024 a 600 nel 2025, con una traiettoria verso le 1000 nel 2030. Non è parità, è accelerazione. La dottrina del “minimum deterrence” rischia di diventare un cimelio accademico. Pechino continua a sbandierare la sua politica di “no first use”, ma intanto costruisce nuovi silos per missili intercontinentali, sperimenta varianti ipersoniche e testa ICBM nel Pacifico. Difesa, certo. Ma il confine tra deterrenza minima e ambizione massima si assottiglia velocemente quando la competizione è con chi possiede arsenali da oltre cinquemila testate.
La farsa del negoziato appare ancora più surreale se si osserva la posizione americana. Washington finge di invocare la stabilità, ma dispiega sistemi Typhon a Guam e nelle Filippine, rafforza AUKUS con Londra e Canberra, e proclama iniziative di difesa missilistica dal nome biblico come “Golden Dome”. Tutto in nome della sicurezza, naturalmente. È la logica del deterrente che si autoalimenta: ogni passo per sentirsi più sicuri crea insicurezza nell’avversario e quindi giustifica un altro passo. La spirale è servita.
Putin, dal canto suo, ha sospeso formalmente New START nel 2023 per punire l’Occidente sul dossier ucraino, ma continua a rispettarne in gran parte i limiti. È il gioco tipico del Cremlino: violare il protocollo, ma aderire alla sostanza per non perdere leva negoziale. Intanto alza il livello di ambiguità sul possibile uso nucleare, trasformando la minaccia in uno strumento quotidiano di politica estera. Trump ci balla attorno con la sua consueta disinvoltura, spostando sottomarini verso il bastione russo e lanciando segnali confusi su quanto sia realmente disposto a rischiare.
Gli analisti americani, da Tong Zhao alla Carnegie a Marc Lanteigne in Norvegia, convergono su un punto: la Cina non entrerà mai seriamente in un trattato sulla falsariga di New START. Non lo farà per principio, perché considera quel quadro un residuato bellico dell’epoca bipolare, e non lo farà per calcolo, perché preferisce trattative bilaterali a pacchetto con Washington, dove il nucleare è solo una componente tra commercio, Taiwan e intelligenza artificiale. In altre parole, Pechino vuole un tavolo da pari con gli Stati Uniti, non una sedia laterale accanto a Mosca.
Intanto la retorica occidentale scivola sul terreno minato delle ipocrisie. Quando il portavoce cinese Guo Jiakun ribadisce che “il Paese con il più grande arsenale nucleare al mondo deve assumersi la responsabilità primaria del disarmo”, il fastidio americano è palpabile, ma la logica inoppugnabile. Washington non può chiedere a Pechino di fermarsi a 600 testate quando ne possiede 5177, di cui 1770 dispiegate. È il classico caso di predicare moderazione con in mano un bazooka.
Se New START scadrà senza eredi nel 2026, il mondo entrerà in un’era di competizione nucleare senza limiti. Non sarà un ritorno lineare agli anni Ottanta, ma un contesto più pericoloso perché tripolare, con variabili aggiuntive come la Corea del Nord, il dossier iraniano, le tentazioni nucleari di Tokyo e Seul. Il paradosso è che, come ricorda Frank von Hippel di Princeton, “in un mondo sano, i tre Paesi hanno già più che abbastanza per scoraggiare qualsiasi attacco, anche due contro uno”. Ma la logica del potere non segue la razionalità aritmetica, segue la paranoia politica.
Pechino gioca di fino. Da un lato si mostra riluttante a un arms control multilaterale, dall’altro intensifica il lessico della responsabilità globale, denunciando la follia di una corsa agli armamenti che nessuno vincerebbe. È una posizione comoda: può accelerare la modernizzazione del proprio arsenale senza dover rispondere a vincoli giuridici, mantenendo la narrativa di Paese moderato che non feticizza la bomba. “La Cina non idolatra le armi nucleari” dice Artyom Lukin da Vladivostok, ed è vero. Ma nel frattempo i suoi silos si moltiplicano nel deserto.
La verità è che Trump, Putin e Xi stanno recitando tre copioni diversi nello stesso teatro. Trump gioca l’imprenditore pro pace che sogna un mondo con “meno armi nucleari” ma solo a patto che il brand America rimanga dominante. Putin si traveste da guardiano della stabilità mentre brandisce il rischio atomico come grimaldello geopolitico. Xi insiste sulla difesa minima ma prepara un arsenale che entro cinque anni potrebbe cambiare gli equilibri strategici in Asia. Tutti fingono di non notare che la traiettoria porta inevitabilmente a una nuova era di instabilità.
Non c’è bisogno di un trattato scritto su pergamena per capire cosa accadrà. Gli Stati Uniti non rinunceranno al primato, la Russia non rinuncerà all’unico strumento che le garantisce ancora status globale, la Cina non rinuncerà alla possibilità di entrare finalmente nel club dei pari. È il classico triangolo impossibile, e non serve la teoria dei giochi per prevedere che nessuno mollerà il pezzo. Von Hippel suggerisce che tutti adottino una politica di “no first use” comune, un impegno logico, quasi banale. Ma la logica non è mai stata la valuta preferita in geopolitica nucleare.
Così la scena resta sospesa in un equilibrio precario, con testate che crescono, trattati che scadono e leader che parlano di pace con un occhio al mirino. L’illusione che bastino due sottomarini spostati o un documento firmato per rassicurare il mondo evapora ogni volta che una nuova base missilistica spunta nelle steppe cinesi o quando Washington annuncia l’ennesimo scudo difensivo. La realtà è che la corsa agli armamenti non ha mai bisogno di dichiarazioni ufficiali per esistere. Ha bisogno solo di diffidenza. E di quella, oggi, ce n’è in abbondanza.