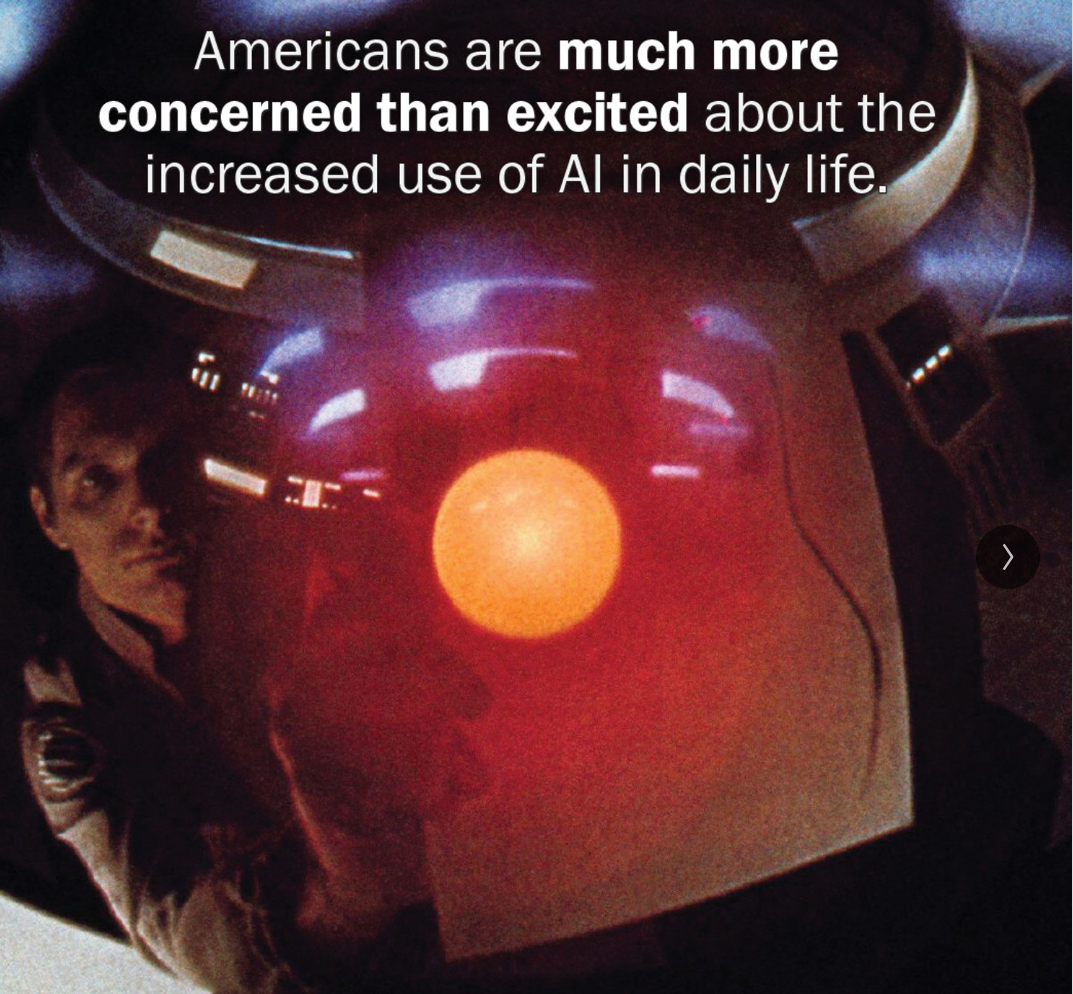È curioso osservare come la patria delle Big Tech, il Paese che ha trasformato il termine Silicon Valley in un marchio globale di innovazione, stia oggi guardando con sospetto la stessa intelligenza artificiale che esporta al resto del mondo. I numeri parlano chiaro: metà degli americani è più preoccupata che entusiasta dell’aumento dell’uso dell’AI nella vita quotidiana. Solo uno sparuto 10% osa dichiararsi “eccitato”. Il resto si posiziona nel mezzo, diviso tra inquietudine e fascino, come chi osserva un’auto senza conducente passare a un incrocio trafficato e si chiede se fidarsi o scappare.
Il punto non è solo statistico, ma culturale. La narrativa ufficiale delle aziende che dominano il mercato globale racconta di un futuro luminoso, fatto di automazione tecnologica che libera tempo e risorse, mentre la percezione della gente comune negli Stati Uniti sembra più vicina a un episodio distopico di Black Mirror che a una campagna pubblicitaria di Microsoft. È un contrasto evidente: da una parte il marketing scintillante delle AI generative, dall’altra la paura di diventare progressivamente inutili o di perdere ciò che ci rende umani.
Quando si chiede agli americani se l’intelligenza artificiale migliorerà o peggiorerà la creatività, il verdetto è impietoso. Oltre la metà pensa che la ridurrà, solo un 16% la vede come catalizzatore di nuove forme espressive. È un dato che dovrebbe far sorridere, se non fosse che si tratta dello stesso Paese che ha trasformato Hollywood e l’industria musicale in macchine globali di produzione culturale. Se la convinzione generale è che l’AI toglierà più che dare, allora il marketing patinato delle piattaforme di AI generativa rischia di essere percepito come l’ennesima promessa di efficienza che si traduce in perdita di originalità. Forse non a caso, la parola “creatività” viene ancora vista come un territorio esclusivamente umano, mentre l’automazione tecnologica, per quanto sofisticata, resta confinata nella sfera dell’utile e del prevedibile.
L’altro fronte caldo è quello delle relazioni significative. Mezzo Paese ritiene che l’AI peggiorerà la capacità di costruirle. Solo un ridicolo 5% osa credere che le migliori. Una condanna senza appello per le startup che si ostinano a vendere algoritmi di matchmaking come se bastasse un prompt per trovare l’anima gemella. Gli americani, evidentemente, non hanno alcuna intenzione di far benedire il loro matrimonio da un chatbot. E non serve tirare fuori l’argomento delle statistiche di Tinder o Bumble: la fiducia sociale resta un bene scarso, e l’idea che l’intelligenza artificiale possa diventare un ponte invece che una barriera nelle relazioni umane viene respinta con un cinismo quasi patriottico.
Il paradosso emerge però quando si guarda ai compiti quotidiani. Qui la narrativa cambia leggermente. Ben il 73% degli americani accetta di far aiutare l’AI almeno un po’. Ma attenzione, non esageriamo: solo il 13% è disposto a lasciarle un ruolo ampio. In pratica la maggioranza vuole l’AI come un assistente discreto, non come un coinquilino invadente. È la logica del “dammi una mano a fare la lista della spesa, ma non osare scegliere la scuola dei miei figli”. Un compromesso tipicamente americano: abbracciare l’innovazione solo fino al punto in cui non mette a rischio il mito della libertà individuale.
E quando la questione si sposta su ambiti personali come religione o relazioni sentimentali, le percentuali diventano quasi grottesche. Il 73% rifiuta qualsiasi ruolo dell’AI nella religione e il 66% la esclude nel matchmaking. È una linea rossa netta, tracciata in un Paese che vive di spiritualità e di romanticismo commercializzato a colpi di San Valentino. Qui non si tratta di tecnologia, ma di identità. Gli americani non vogliono un algoritmo a predicare dal pulpito o a suggerire con chi passare la vita. Curiosamente, però, si dichiarano molto più aperti a concederle spazio in aree ad alto tasso di dati e bassa emotività, come le previsioni meteorologiche o le indagini su crimini finanziari. Forse perché lì non si tocca la sfera personale, ma si sfrutta al massimo la capacità di calcolo che l’uomo non potrà mai eguagliare.
La percezione dell’intelligenza artificiale diventa ancora più interessante quando si parla di contenuti. Il 76% degli americani dichiara di voler sapere con certezza se un testo, un video o un’immagine siano generati da un umano o da una macchina. È una domanda di trasparenza che sembra banale, ma che mette a nudo il cuore del problema: la fiducia. La maggioranza non si fida, e ancor peggio non si fida nemmeno della propria capacità di distinguere. Più della metà confessa di non sentirsi affatto sicura nel riconoscere un contenuto artificiale. Il risultato è un cortocircuito perfetto: voglio sapere se ciò che vedo è autentico, ma non ho gli strumenti per capirlo. È come vivere in un mondo di deepfake costanti, dove l’occhio umano è già dichiarato obsoleto.
Il sospetto che traspare da questi dati è che la retorica della Silicon Valley stia iniziando a incrinarsi proprio dentro i confini nazionali. L’idea che l’intelligenza artificiale sia un progresso inevitabile, quasi un destino tecnologico, non convince più l’opinione pubblica americana. O meglio, convince solo quando si tratta di calcoli, previsioni e automazione invisibile. Non appena si tocca la sfera umana, la resistenza emerge con forza. È come se gli americani dicessero: “Va bene, aiutaci a trovare una frode finanziaria da miliardi, ma non provare a insegnarci a pregare o a innamorarci”.
Questa schizofrenia culturale merita attenzione perché mostra una frattura tra chi produce la tecnologia e chi la subisce. L’industria racconta l’AI come strumento di empowerment, i cittadini la vedono come minaccia al pensiero critico e alla socialità. Il risultato è un dialogo tra sordi che rischia di trasformare la narrazione globale sull’intelligenza artificiale. Non è un caso che gli stessi imprenditori della tecnologia, da Musk a Altman, parlino apertamente dei rischi, quasi per anticipare le critiche e gestirle. Ma la gente comune non si accontenta di disclaimer paternalistici. Se metà degli americani vede l’AI come una forza di erosione della creatività, significa che il messaggio di fiducia non arriva, e forse non arriverà mai.
Vale la pena riflettere su come questa percezione possa influenzare la politica. Negli Stati Uniti, dove ogni elezione è una battaglia di narrativa, la sfiducia popolare nell’automazione tecnologica diventerà inevitabilmente un tema da cavalcare. Nessun candidato perderà l’occasione di dipingersi come difensore del lavoro umano e della creatività americana contro le macchine senz’anima. Già oggi si vedono segnali di questo populismo tecnologico, che mescola paure concrete a slogan semplificati. In fondo, non è molto diverso da ciò che accade con l’immigrazione o il cambiamento climatico: la tecnologia diventa terreno di scontro identitario più che di valutazione razionale.
Alla fine, il grande equivoco è che l’intelligenza artificiale non è mai stata solo tecnologia. È un campo di battaglia culturale e politico, dove la retorica della Silicon Valley si scontra con l’istinto di conservazione dell’individuo. Gli americani sembrano voler dire che non sono pronti a cedere la loro creatività, le loro relazioni e la loro spiritualità a un algoritmo. Accettano la comodità di un assistente che ricorda un appuntamento o calcola una probabilità, ma rifiutano l’idea che la stessa intelligenza artificiale diventi guida morale o sostituto affettivo. È una forma di pragmatismo misto a paranoia, tipicamente americana, che forse rappresenta l’unico antidoto all’ubriacatura globale per l’AI generativa.