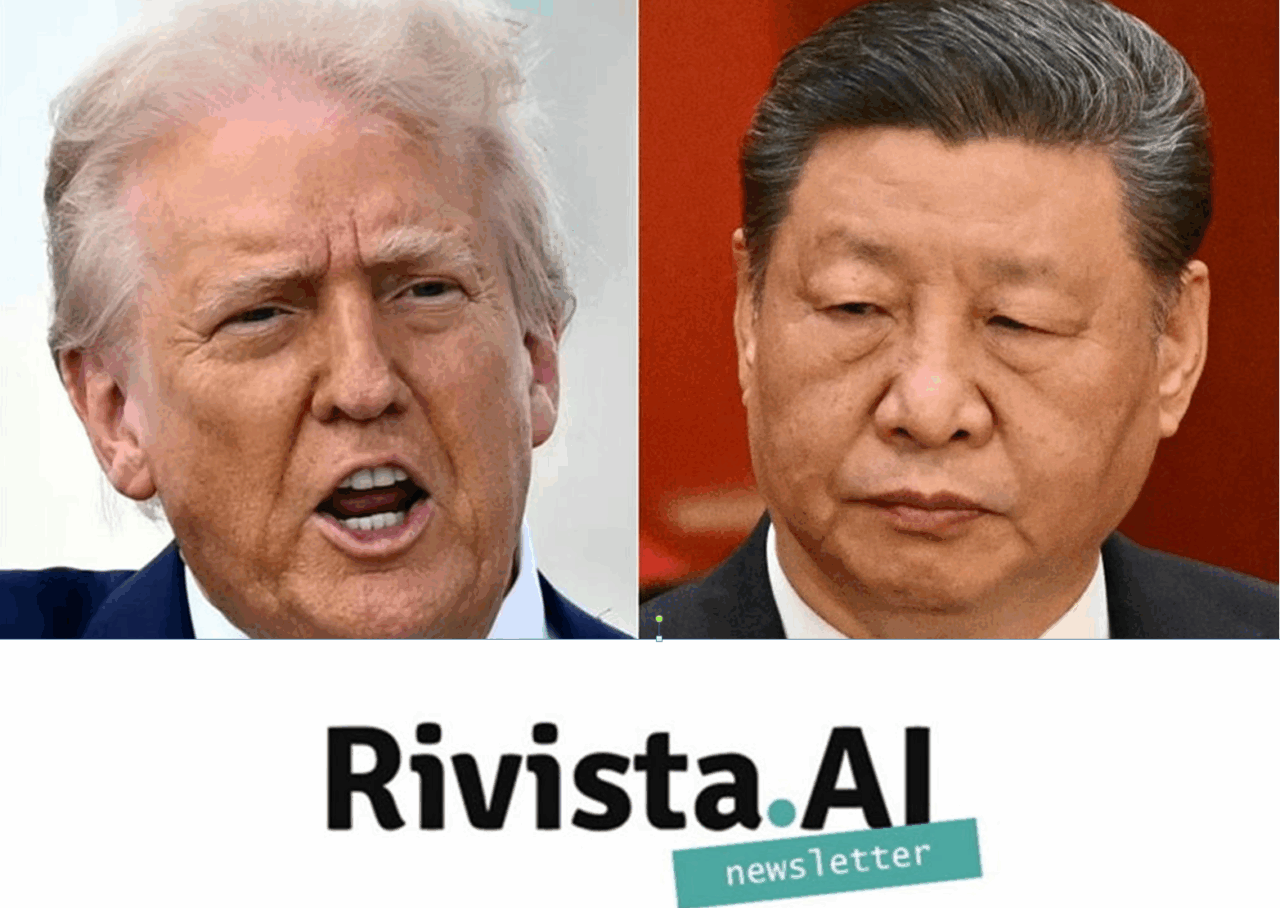Un’altra volta ci siamo trovati nel mezzo dello scontro tra giganti, e no, non come protagonisti. Come comparsa malvestita sul set sbagliato. Mentre Stati Uniti e Cina giocano a Risiko commerciale lanciandosi tariffe come freccette ubriache al bar di fine serata, l’Europa resta ferma sullo sgabello a fissare il bicchiere vuoto, chiedendosi quando è successo che ha smesso di contare qualcosa.
Il punto non è che ci siano stati colloqui tra Washington e Pechino – quelli sono inevitabili, come i cerotti dopo le scazzottate. Il punto è come si sono chiusi. Gli USA, guidati dal solito Trump in modalità “Reality Show Diplomacy”, annunciano trionfi storici, tariffe dimezzate, vittorie strategiche. La Cina, dall’altra parte, non solo esce con un’economia più tutelata, ma soprattutto con un’immagine geopolitica rafforzata. E noi? Abbiamo commentato. Forse.
La verità cruda, che puzza più di una mensa scolastica al venerdì, è che Pechino è riuscita a giocare la partita senza mai sedersi davvero al tavolo. La sua forza è quella del silenzio strategico, del rifiuto calcolato, del “possiamo permetterci di andarcene”. E come diceva un vecchio broker nel cuore di Londra: “Quello che può mollare il tavolo ha già vinto.”
Washington, nel frattempo, ha simulato il classico “deal” hollywoodiano, tutto fumo e tweet, riuscendo nel piccolo miracolo di sembrare forte mentre si ritira. Trump si prende la scena, annuncia la pace commerciale, e intanto il danno strutturale all’ordine multilaterale è compiuto. Il sistema di alleanze, le regole del commercio, l’OMC stessa tutto ignorato. Ma chi se ne frega, finché puoi dire al tuo elettorato che hai fatto “America First” con stile.
Nel frattempo Pechino lancia segnali chiarissimi: possiamo combattere, possiamo resistere, e soprattutto possiamo permetterci di restare in piedi da soli. Un lusso che Bruxelles può solo sognare, tra vincoli di bilancio e telefonate indecise.
E qui sta il punto dolente. L’Europa non è solo stata esclusa dal tavolo: è stata anche incapace di reagire. Parole vaghe, appelli al multilateralismo, ma nessuna contromisura. India? Sulla stessa barca. Parole senza strategia. L’unico asse che conta, nel 2025, è quello USA-Cina. E ogni azione bilaterale o multilaterale al di fuori di questo asse appare, al massimo, come folklore geopolitico.
Il tutto avviene mentre gli USA mantengono, con l’ipocrisia di chi sa vendere bene le armi e le narrazioni, un’agenda aggressiva mascherata da difesa nazionale: decoupling strategico, protezionismo mirato, politiche industriali da tempo di guerra. I dazi “liberatori” scendono, ma solo per 90 giorni, come fossero antibiotici per un’infezione cronica. E non si tratta di abbandonare il confronto, ma di ridisegnare le regole per combatterlo meglio in seguito.
Nel frattempo, Pechino si porta a casa tre trofei invisibili: credibilità internazionale, resistenza economica e controllo del tempo. Perché mentre gli americani parlano di deal, la Cina guarda a decenni. E come disse una volta un funzionario cinese a un diplomatico europeo: “Voi pensate alle elezioni. Noi pensiamo ai secoli.” Tanti auguri, Bruxelles.
Poi c’è l’aspetto teatrale. Il People’s Daily, con una sobrietà che nemmeno l’Avvenire, dichiara che le trattative si sono svolte “su un piano di parità”. Cioè, Trump grida, la Cina resta composta. Uno spaccato perfetto della nuova Guerra Fredda 2.0: una superpotenza mediatica contro una superpotenza silenziosa. E nel mezzo, una Unione Europea che forse è ancora convinta che il soft power funzioni se detto con abbastanza accento francese.
Nel sottotesto di tutto questo ci sono i veri dossier caldi. Fentanyl, semiconduttori, terre rare. Si parla di accordi paralleli, come se tutto si potesse spezzettare in comparti stagni. Ma nessuna trattativa è neutra quando i soggetti sono i due dominatori del nuovo ordine multipolare. Ogni clausola è un posizionamento strategico. Ogni dazio rimosso è un test per i margini di manovra futuri.
Quello che impressiona è come gli USA abbiano comunque mantenuto l’illusione di controllo, pur dovendo retrocedere. Una lezione di comunicazione politica brutale e chirurgica: anche la ritirata, se fatta con bandiere e trombe, sembra un’entrata. Ma sotto la superficie, resta il fatto che non hanno ottenuto il decoupling desiderato. La Cina, nel frattempo, ha costruito la propria autonomia industriale durante il caos della pandemia, e ora è meno dipendente che mai.
Il dramma europeo è questo: mentre gli altri si rafforzano anche nelle crisi, noi ci dividiamo, analizziamo, conferenziamo. Il dibattito interno tra “più Europa” e “meno Bruxelles” è il diversivo perfetto per evitare di parlare del vero fallimento: l’assenza di una politica estera e commerciale comune degna di questo nome.
E quindi, rieccoci. A osservare. A fare commenti. A pubblicare paper sull’importanza della resilienza economica. Ma senza potere di negoziazione. Senza muscoli industriali. Senza visione geopolitica. Solo buoni propositi e bandiere blu con stelline gialle.
Che figura barbina.

Anche l’America non ride e gli effetti si vedranno tra un paio d’anni
Trump, il suo “nuovo” impero finanziario e quel tocco da grande showman che sembra non finire mai. Non è mai stato il tipo da mezze misure, e adesso, con l’ingente investimento di 2 miliardi di dollari, riesce a destare più di qualche preoccupazione nei corridoi di Washington. Le ultime voci parlano di mega-grattacieli, aerei privati e una serissima puntata sul futuro delle criptovalute. Un’operazione che solleva più di un dubbio, un vero e proprio conflitto di interessi che sembra svettare alto quanto la Trump Tower stessa.
Un investimento di 2 miliardi non è esattamente una cifra da “piccole imprese”, e seppur Trump non sia nuovo a queste mosse (come se la politica fosse solo un grande palcoscenico), la quantità di denaro in gioco, associata alla sua retorica politica, mette in luce un gioco che potrebbe danneggiare il sistema a lungo termine. Se a questo aggiungiamo il contesto internazionale, come la recente espansione dei suoi affari nel Medio Oriente, la lettura diventa ancora più complessa. Ma andiamo con ordine.

Partiamo dal punto focale: il conflitto di interessi. Immaginate di avere nelle mani la Casa Bianca, il controllo di una nazione che possiede il monopolio del nucleare e che può dettare legge a livello globale. E adesso, immaginate anche di avere in atto un piano da miliardi di dollari che coinvolge grattacieli, aerei e investimenti in settori (come le criptovalute) che potrebbero essere, in potenza, oggetto di regolamentazioni a livello federale. È un cocktail pericoloso, un mix letale di potere economico e politico che potrebbe rivelarsi una bomba ad orologeria. La domanda è: quanto un interesse così grande, un legame tra il business privato e la politica pubblica, possa essere sostenibile in una democrazia che teoricamente punta sulla separazione dei poteri?

Al Financial Times, l’analisi di queste mosse è più sottile e tecnica, ma non meno critica. Se è vero che Trump è riuscito a cavalcare la sua visibilità politica per attrarre enormi investimenti, è altrettanto vero che l’analisi dei suoi legami economici con la politica solleva non poche perplessità. Le criptovalute, in particolare, rappresentano un mercato altamente volatile, perfetto per qualcuno che potrebbe approfittare di regolamenti troppo laschi o di ritardi governativi per fare soldi, al netto di rischi enormi per gli investitori più piccoli.
Poi c’è l’altra parte del racconto, quella che coinvolge il Medio Oriente. Trump, con la sua posizione di ex-presidente, ha creato una rete di contatti che trascende la politica, in cui il settore privato e quello pubblico si mescolano in modo piuttosto ambiguo. Tra i suoi investimenti, quelli diretti al Medio Oriente potrebbero nascondere più di una semplice strategia economica. Se le criptovalute sono l’oggetto del futuro, il nucleare sembra essere l’infrastruttura del presente per molti stati della regione. Con Trump che sembra avere i suoi legami personali con alcune di queste nazioni, la questione si complica. È davvero possibile che il futuro della politica energetica mondiale possa essere influenzato da un uomo che, oltre a mantenere l’influenza sulla Casa Bianca, si preoccupa anche di cosa accade nel deserto?
Gli Stati Uniti, dal canto loro, stanno cercando di mantenere un equilibrio molto fragile. Da una parte, Trump è ancora un personaggio che esercita un fascino potente tra i suoi sostenitori. Dall’altra, la sua figura è perennemente sotto la lente degli analisti e dei critici. Il Financial Times, in particolare, sottolinea come il mix tra politica, business e relazioni internazionali di Trump possa far emergere una forma di “imperialismo economico”, dove gli interessi personali si sovrappongono a quelli statali. Non si può non notare come la Casa Bianca, all’epoca della sua presidenza, sia stata teatro di una gestione piuttosto orientata verso interessi privati, quasi come se gli Stati Uniti fossero diventati una sua estensione aziendale.
Eppure, nonostante il discorso moralista che tanti si sforzano di fare, la realtà è che Trump ha trasformato il conflitto di interessi in una forma di arte. La sua capacità di connettere il mondo degli affari con la politica è innegabile. Forse, questa capacità è stata la sua forza e la sua debolezza, perché un sistema che mescola troppi ingredienti rischia di esplodere. La questione del nucleare, le criptovalute e gli investimenti miliardari sono solo alcune delle tessere di un puzzle che si fa sempre più intricato.
Nel frattempo, la geopolitica si fa sempre più affollata, e Trump, da un angolo, osserva. Non c’è dubbio che il suo ritorno sulla scena politica possa riaccendere quella scintilla che ha acceso il mondo degli affari. Ma a quale prezzo? Forse quella scintilla potrebbe rivelarsi troppo esplosiva, come una bomba a orologeria che alla fine esploderà, lasciando il mondo a contare i danni.
Quindi, come viene visto Trump oggi? La sua immagine è complessa, avvolta in un mix di ammirazione e sdegno. Un magnate dei media che ha dominato la scena politica, mescolando affari e politica come se fossero la stessa cosa. Gli Stati Uniti, forse, dovranno imparare a fare i conti con questa realtà, e chissà se la futura classe dirigente sarà pronta ad affrontare una simile amalgama di potere privato e pubblico.