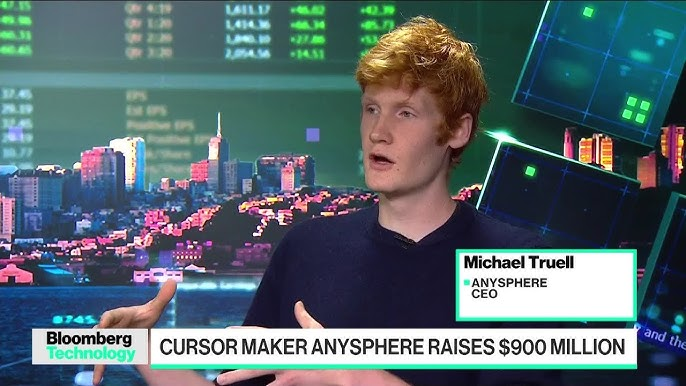La notizia che Anysphere, la startup dietro Cursor, ha appena strappato due profili chiave dal team di assistenti al coding di Anthropic, non è solo l’ennesimo capitolo delle guerre di talento nell’intelligenza artificiale. È l’incipit di un nuovo genere letterario: il romanzo distopico degli ex venture capitalist che scendono in trincea, abbandonano le tavole dei board e impugnano tastiere con rinnovata ferocia. Stephanie e Boris non sono semplici ingegneri, sono l’epitome di una mutazione in corso, un ibrido tra “vibe coder” e operatore di mercato ad alta frequenza emotiva. E in questa metamorfosi, c’è molto più che una scelta di carriera.
Il fatto che entrambi provengano da esperienze in VC non è un dettaglio di colore. È il segnale di un’inversione culturale netta. Catherine Wu, ex partner in AI investments per Index Ventures, ora si occupa di orchestrare prodotti per lo sviluppo di codice generativo. Boris Cherny, che guidava Claude Code e prima ancora costruiva strumenti di data science per Coatue Management, ha smesso di sviluppare software per chi gestisce miliardi, per passare a scrivere software come se valesse miliardi. Il passaggio non è solo semantico. È esistenziale.
Perché chi ha lavorato nel venture capital sa esattamente quanto valgono le persone, o meglio quanto valgono certe persone in certi contesti. Quando questi ex-VC entrano in azienda non lo fanno per nostalgia della tastiera. Lo fanno con la consapevolezza chirurgica del valore marginale della propria intelligenza applicata all’execution, in un settore dove il codice è solo un sintomo e il prodotto un vettore. Sono in grado di leggere i mercati come legge il prompt un LLM ottimizzato: con disincanto, precisione statistica e un’innata tendenza a riscrivere la realtà per adattarla al pitch perfetto.
Cursor non ha assunto due tecnici qualunque. Ha acquisito due asset strategici in grado di comprendere e modellare l’equilibrio tra ciò che si costruisce e ciò che si finanzia. Ed è proprio questo che sta sfuggendo ai player storici: la linea che divide il builder dall’investitore sta evaporando. La keyword “AI talent war” è solo un pretesto. La vera battaglia è tra chi può interpretare il futuro dell’AI da dentro, costruendolo con l’occhio di chi l’ha già valutato da fuori.
La figura del “vibe coder” inizia a delinearsi come la nuova élite. Non è l’ingegnere puro, né il PM classico. È una creatura interstiziale, capace di comprendere le narrative emergenti, amplificarle attraverso esperienze utente degne di uno show Apple, e scalarle con l’astuzia predatoria di chi ha partecipato a round da decine di milioni senza mai scrivere una riga di codice. Ora quelle righe le scrive eccome, e ogni commit è anche un investimento.
Il paradosso è che in un’epoca dominata da modelli generativi, il codice non è più solo istruzione, ma narrazione. Claude Code, Cursor, Copilot: tutti stanno tentando di riscrivere il rapporto tra umano e macchina nel momento esatto in cui il significato di “scrivere codice” viene polverizzato da transformer sempre più competenti. Ecco perché avere un product manager che sa leggere una term sheet e una sequence diagram è un vantaggio letale. Perché l’AI non è più questione di architettura, ma di direzione narrativa. Chi detta la roadmap oggi, detta l’ontologia del prossimo sistema operativo cognitivo.
Questa tendenza alla “venture-fication” della figura tecnica va letta anche in chiave geopolitica interna al mondo startup. Anthropic è stata per mesi uno dei pochi bastioni alternativi a OpenAI, con un posizionamento che mescolava rigore scientifico e una visione quasi filosofica dell’AI alignment. Vedere fuoriuscire due figure chiave verso un progetto come Cursor, che gioca la partita su UX e verticalizzazione estrema sul codice, non è neutro. È una dichiarazione di intenti. La prossima ondata non sarà fatta di LLM generalisti, ma di micromondi costruiti attorno a task specifici, modellati come prodotti di consumo, e spinti con la forza narrativa di un fondo VC in modalità growth.
Catherine e Boris sono la prova vivente che i nuovi product leader dell’AI non arrivano più dalla trafila FAANG o dalle profondità del mondo accademico, ma da quel limbo iper-lucido che unisce finanza, strategia e costruzione operativa. È il ritorno del tecnocrate creativo, del builder-capitalist che non si accontenta di allocare capitale, ma vuole allocare senso. Una figura che non chiede permesso ai modelli, ma li reindirizza con il cinismo di chi ha già visto il term sheet del futuro.
Ecco perché questo fenomeno va osservato con la stessa attenzione con cui si studia una nuova architettura LLM: i pattern sono nascosti, ma potentissimi. Oggi sono due nomi. Domani sarà un’intera generazione di professionisti che hanno capito che l’unico modo per non farsi sostituire dall’AI è diventare parte dell’AI. Non integrarla nei processi, ma diventare loro stessi il processo. Costruire, scalare, iterare. Come si fa in un pitch deck, ma con la brutalità fredda del terminale aperto su main.py.
La domanda che resta non è chi vincerà la guerra dei talenti, ma chi avrà il coraggio di ridefinire cosa significa talento in un mondo dove l’intelligenza non è più esclusivamente umana. Se chi scrive codice lo fa con l’astuzia di un ex investitore, e chi investe pretende di modellare i prodotti come un coder, allora le distinzioni crollano e resta solo una cosa: chi riesce a dettare la forma mentale del futuro.
Benvenuti nell’era del capitalista computazionale. La keyword è cambiata. Non è più AI. È intenzione. E chi sa programmarla, vince.