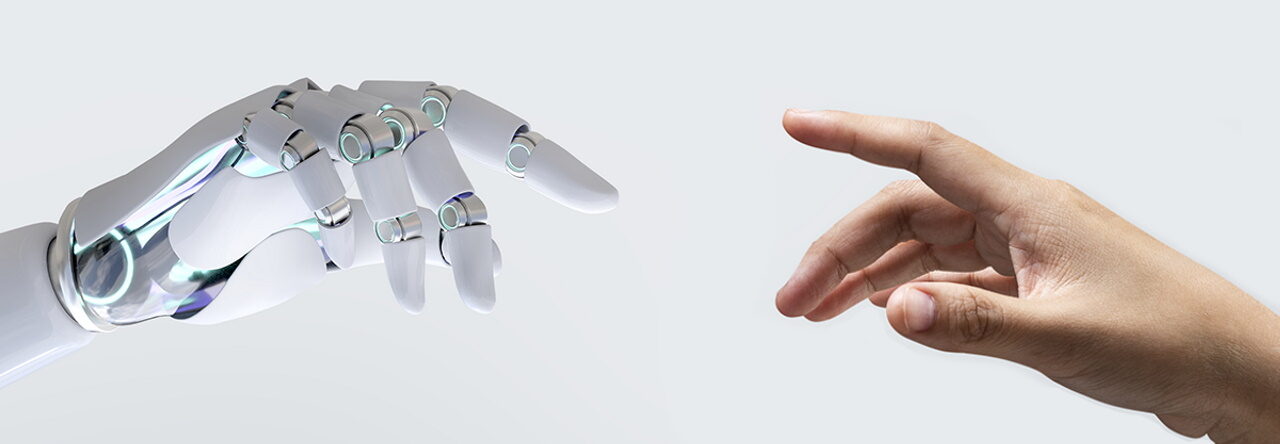C’era una volta un programmatore che scriveva codice riga dopo riga, contava le parentesi e bestemmiava dietro ai puntatori. Poi sono arrivati i data scientist, che invece di scrivere software, lo “allenavano”. E adesso, nella parabola kafkiana del progresso tecnologico, siamo tutti diventati stregoni verbali: pronunciamo comandi e otteniamo miracoli. Benvenuti nel Software 3.0, dove non scrivi, non compili, non deployi. Promp-ti. Parli al sistema. E il sistema obbedisce. Più o meno.
Andrej Karpathy, ex direttore dell’intelligenza artificiale di Tesla e co-fondatore di OpenAI, lo dice senza mezzi termini: “Code you prompt”. Non è una boutade. È l’equivalente software della scoperta del fuoco, ma col sospetto che potremmo bruciarci vivi. Perché, come sempre, la semplicità apparente nasconde una complessità nuova, ancora non del tutto compresa nemmeno da chi plasma questi modelli.
Il suo intervento alla Y Combinator AI Startup School è una di quelle 30 minuti che vanno guardate, riviste, digerite a colazione con pane integrale e caffè forte. Non perché dica cose mai sentite, ma perché le mette in fila con una chiarezza chirurgica che ti fa pensare: “Dannazione, ma allora è tutto vero”.
Partiamo dalla teoria dei tre paradigmi del software: il Software 1.0 era scritto a mano, controllato, deterministico. Il Software 2.0 veniva addestrato su grandi moli di dati, ottimizzato con backpropagation e loss function. E il Software 3.0? È quello che si ottiene con una richiesta in linguaggio naturale. Letteralmente, software generato al volo, senza pipeline, senza CI/CD. Software che vive nel contesto, non nel codice.
Ecco il nodo. Il contesto. Le LLM, i modelli linguistici di nuova generazione, non sanno nulla e sanno tutto contemporaneamente. Sono simulazioni stocastiche di esseri umani, scrigni probabilistici di conoscenza implicita, trained on the internet, ma senza alcuna memoria duratura. Karpathy li chiama “people spirits”, e l’immagine è perfetta: sono spiriti evocati nel momento, performano una coscienza temporanea e poi svaniscono nell’etere quantico del GPU cluster.
E se questo suona mistico è solo perché ancora non abbiamo trovato un linguaggio tecnico per descrivere quello che sta succedendo. Perché nel 2025 non avremo ancora le self-driving AI di cui favoleggiava Silicon Valley dieci anni fa. Ma saremo pieni di semi-agenti, di assistenti parzialmente autonomi, di LLM che svolgono compiti specifici, orchestrati da altri LLM, in una struttura gerarchica degna della burocrazia romana.
Karpathy lo dice con la calma di chi sa: gli LLM sono i nuovi sistemi operativi. Non solo perché girano ovunque, ma perché diventano lo strato attraverso cui interagiamo con il software stesso. Come nel 1965, quando i primi OS astratti permisero di separare hardware e codice, oggi separiamo logica e conoscenza. Il prompt è l’interfaccia. L’output è il codice. Ma tra input e output si muove una creatura instabile, intelligente a tratti, idiota in altri, affetta da quella che lui chiama “anterograde amnesia”: nessuna memoria a lungo termine, solo contesto temporaneo.
Qui entra in gioco il tema centrale: la gestione del contesto. Chiunque stia costruendo un prodotto AI sa che il vero incubo non è generare un testo. È mantenerne la coerenza, tracciare gli stati, conservare una “storia” operativa, implementare una pseudo-memoria che non sia solo un appendice su un vector database. Il prompt engineering è morto, viva l’orchestrazione multi-LLM. E sì, è tutto molto più vicino alla direzione d’orchestra che al coding in senso tradizionale.
Ed è per questo che il software moderno torna a essere visivo. Karpathy lo dice chiaro: “Le interfacce testuali sono lente, le GUI specifiche sono l’unica via”. Non si tratta solo di UX. È una questione epistemologica: il linguaggio è ambiguo, la GUI è vincolata. L’interfaccia grafica serve per accelerare la verifica, non per facilitare l’input. La generazione è ormai un costo marginale. La verifica, invece, è dove si annidano il rischio e la fatica.
In questo nuovo mondo, scrivere codice è un privilegio obsoleto. Letteralmente tutti possono “programmarsi” qualcosa. Non serve sapere cosa sia un loop, basta formulare il desiderio. Karpathy lo chiama “vibe coding”, come se bastasse l’atmosfera giusta per tirare fuori un’app. E in un certo senso è così. Le barriere sono cadute. Il gatekeeping è saltato. Ma come ogni rivoluzione, anche questa ha il suo backlash: DevOps è il nuovo collo di bottiglia. La magia funziona, ma farla girare in produzione richiede ancora i vecchi riti tribali di provisioning, deploy, logging, scaling. Insomma, la noia.
E intanto il mercato si riempie di illusioni. Gli agenti sono ovunque, le demo si moltiplicano. Ma come nel 2013, quando Karpathy salì sulla prima auto a guida autonoma e si accorse che non era poi così autonoma, il sogno dell’agente AI che opera da solo è ancora lontano. L’autonomia completa è una chimera. Quella vera, quella utile, è l’autonomia controllata, a slider. Meccanismi semi-automatici dove l’umano può dosare il coinvolgimento. Perché l’agente totalmente autonomo è pericoloso, inefficiente e, ancora oggi, profondamente stupido in alcuni contesti chiave.
Ma proprio qui arriva la svolta. Perché i consumatori stanno guidando l’adozione, non le aziende. Ed è una rottura del paradigma classico. L’impresa, da sempre regina dell’innovazione, oggi rincorre il consumatore che gioca con ChatGPT sul telefono. È il prosumer a dettare il passo, il knowledge worker frustrato che costruisce un workflow LLM su Notion o Zapier e supera la produttività del suo intero reparto IT. È l’inversione definitiva: il B2C sta colonizzando il B2B. Con prompt, API e fantasia.
Sembra tutto assurdo, eppure è già realtà. Chi guida l’adozione del Software 3.0 sono individui. Freelance, designer, markettari con un po’ di logica. Non CTO, non system architect. E questo sposta l’asse del potere. Perché il software, una volta controllato da pochi, diventa intelligenza a noleggio disponibile a tutti. Ma senza standard, senza architettura, senza coerenza. Una distopia di creatività disorganizzata, che solo pochi saranno in grado di dominare.
E allora, cosa ci resta? La strategia. L’unico vero vantaggio competitivo nell’era dell’AI senza memoria, del software che parla ma non ascolta, del codice che non si legge ma si verifica. In questo mondo, saper orchestrare, selezionare, modulare è più importante che programmare. Il vero programmatore oggi è un meta-architetto, un filosofo dell’interazione tra modelli, un demiurgo di contesti e istruzioni.
Il software nell’era dell’intelligenza artificiale non si scrive. Si dirige. E chi non sa dove vuole andare finirà per affidarsi a un prompt sbagliato, a un modello sbagliato, a una realtà costruita da altri. Il futuro non è nelle mani di chi sa programmare, ma di chi sa pensare in modelli. Perché come diceva un certo Marvin Minsky, “you don’t understand something until you can program it”. Ma oggi, forse, basta solo chiederlo bene.