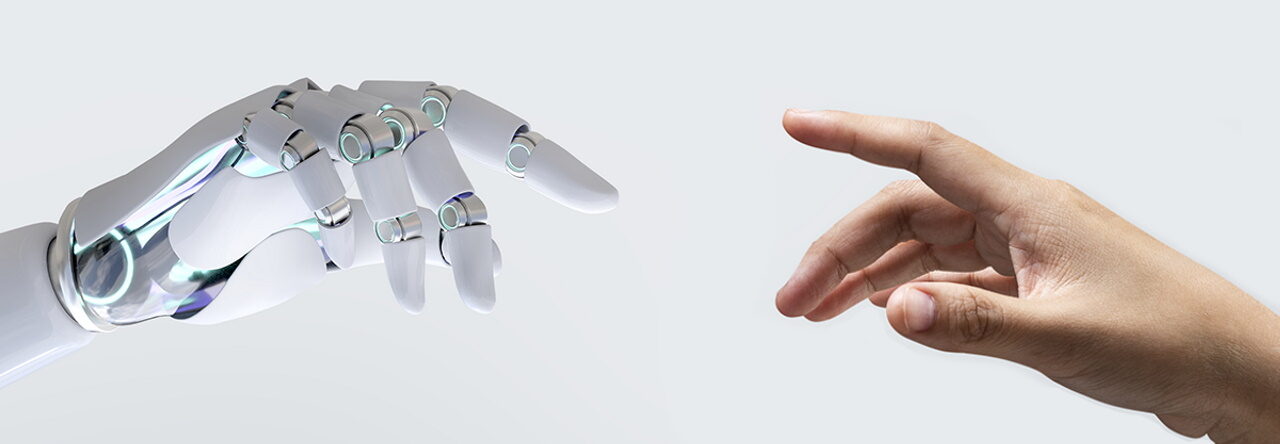Nell’era in cui l’AI scrive poesie, licenzia middle manager e prevede i nostri desideri prima che li esprimiamo, è facile restare indifferenti a ogni nuovo exploit digitale. Ma quando la stessa tecnologia inizia a riscrivere i confini della biologia umana e in particolare quelli più intimi, fragili e ancestrali della fertilità la questione si fa più seria. E anche un po’ disturbante. Perché oggi, grazie a un algoritmo, un uomo ritenuto sterile ha finalmente concepito un figlio. Tre spermatozoi. Tanto è bastato. Il miracolo? Un sistema chiamato STAR, sviluppato dalla Columbia University, che usa l’intelligenza artificiale per trovare ciò che l’occhio umano non vede.
Il caso è quello di una coppia che ha combattuto per 18 anni contro il silenzio imbarazzante dell’azoospermia, quella condizione enigmatica in cui lo sperma sembra esserci ma, a ben guardare, non c’è. Nessuna coda che guizza nel vetrino, nessun nuoto sincronizzato verso l’utero. Solo frammenti, detriti, il deserto. Dopo innumerevoli cicli di fecondazione in vitro, viaggi transcontinentali nei templi mondiali della fertilità e promesse infrante da microscopi e bisturi, avevano quasi smesso di crederci. Quasi. Perché poi è arrivato STAR acronimo che suona hollywoodiano ma che qui sta per “Sperm Tracking and Recovery” e ha trovato la vita nel nulla.
Lo ha fatto con lo stile brutale e inesorabile delle macchine: oltre otto milioni di immagini analizzate in meno di un’ora, un algoritmo addestrato con milioni di pattern morfologici, una videocamera ad alta velocità collegata a un microscopio con chip proprietario. Niente laser, niente coloranti. Solo visione computazionale e apprendimento profondo. Il sistema ha isolato tre spermatozoi vivi in un campione che i tecnici, per giorni, avevano giudicato completamente sterile. Tre cellule. Una fecondazione riuscita. Una gravidanza in corso. E un parto previsto per dicembre.
Ora, facciamo una pausa. Perché il punto qui non è solo il successo del caso singolo, né l’inevitabile romantizzazione del “miracolo della vita”. Il punto è che l’intelligenza artificiale sta cominciando a intervenire in uno dei processi biologici più antichi e delicati dell’umanità, quello della riproduzione sessuata, e lo sta facendo con la stessa logica con cui vince a Go, guida le Tesla o scrive codici Python. Non crea spermatozoi, ma li trova. Non cura l’infertilità, ma la scavalca. E soprattutto: non chiede il permesso. Ci guarda dentro meglio di quanto sappiamo guardarci noi. Anzi, per dirla con le parole di un medico coinvolto nello sviluppo del sistema, “ci mostra quello che i nostri occhi non possono vedere”.
Sembra poesia, ma è matematica. Perché l’infertilità maschile, a dispetto del machismo culturale e delle rassicurazioni sessuali, è responsabile del 40% dei casi totali di sterilità di coppia. E l’azoospermia, la più invisibile tra le sue varianti, affligge il 10% degli uomini infertili. In passato, l’unica strada percorribile era la chirurgia invasiva dei testicoli – escissioni dolorose alla ricerca di qualche spermatozoo nascosto – o, peggio, l’adozione di gameti da donatore. Ora, invece, si può provare a fare quello che la Columbia University ha appena fatto: applicare la logica brutale dell’AI per trovare il minimo biologico necessario per avviare una nuova vita.
Certo, non tutti applaudono. Alcuni esperti sottolineano come questi sistemi siano ancora lontani dalla validazione clinica. Altri fanno notare che, in molti casi, il problema resta: se lo spermatozoo non c’è, non c’è, punto. Anche l’algoritmo più sofisticato del mondo non può generarlo dal vuoto. Gianpiero Palermo – lo stesso che ha inventato la tecnica dell’iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo, ormai standard globale – è scettico: “Alcuni uomini semplicemente non hanno spermatozoi, e nessuna AI potrà cambiarlo”. Ma, si sa, la scienza non è mai unanime. E ogni nuova tecnologia in medicina è accompagnata da onde parallele di entusiasmo e sospetto.
Quello che però è difficile ignorare è il senso di rottura epistemologica che questa storia rappresenta. Per millenni, l’infertilità è stata una questione privata, spesso attribuita a colpe morali, punizioni divine o incapacità sessuale. Oggi diventa una sfida tecnica, un problema di risoluzione delle immagini, un algoritmo di riconoscimento. È come se avessimo preso uno dei misteri più profondi della condizione umana e lo avessimo consegnato a una macchina per farne data mining. È tutto molto post-umano, nel senso più autentico del termine.
E se la fertilità maschile è solo l’inizio? Già ora AI come CHLOE e Stork-A vengono utilizzate per valutare la qualità degli ovociti, predire il successo dei cicli di fecondazione e personalizzare i protocolli farmacologici. Embriologi digitali analizzano le divisioni cellulari in tempo reale e suggeriscono, con una precisione superiore all’intuizione umana, quale embrione impiantare. L’idea che la procreazione sia un atto intuitivo, passionale o almeno umano, sta lentamente sfumando. O forse si sta semplicemente evolvendo, come tutto il resto.
Per i cinici, è l’ennesimo esempio di medicalizzazione della vita: l’utero come laboratorio, l’amore come combinazione statistica, la nascita come output algoritmico. Per altri, invece, è l’apertura di una nuova frontiera di speranza, dove anche l’invisibile può diventare concreto, anche il fallimento può essere riscritto in codice. A pensarci bene, entrambe le letture sono vere. Il confine tra eugenetica soft e biotecnologia salvifica è sempre più sottile. E il futuro della riproduzione potrebbe non essere tanto una scelta privata, quanto una funzione tecnologica, mediata da modelli predittivi e immagini a milioni di pixel.
C’è qualcosa di poeticamente inquietante nel fatto che, alla fine, siano serviti 8 milioni di immagini per trovare tre cellule. È come se la riproduzione umana avesse dovuto piegarsi alla logica dei big data per funzionare. È come se la scienza ci stesse dicendo: la vita è ancora possibile, ma solo se accetti di guardarla diversamente. Solo se lasci che sia un’intelligenza artificiale a dirtelo.
In fondo, non è la prima volta che la tecnologia ci permette di superare i nostri limiti biologici. Ma quando si tratta di fare un figlio, e quando l’atto procreativo viene filtrato attraverso lenti digitali, microscopi intelligenti e decisioni computazionali, la posta in gioco cambia. Non è solo una questione di successo clinico. È una questione di significato. E forse, anche, di identità.
Quella coppia che per 18 anni ha lottato contro il silenzio dell’azoospermia non ha solo ottenuto una gravidanza. Ha partecipato, consapevolmente o meno, alla riscrittura del concetto stesso di fertilità. In un mondo dove il dato è più affidabile del desiderio, dove gli spermatozoi si trovano con lo stesso metodo con cui si scovano anomalie nel bilancio di una multinazionale, forse anche la vita stessa sta diventando un prodotto dell’intelligenza artificiale.
E se è vero che l’AI non può creare spermatozoi, può però cambiare tutto quello che facciamo quando crediamo che non ci siano.