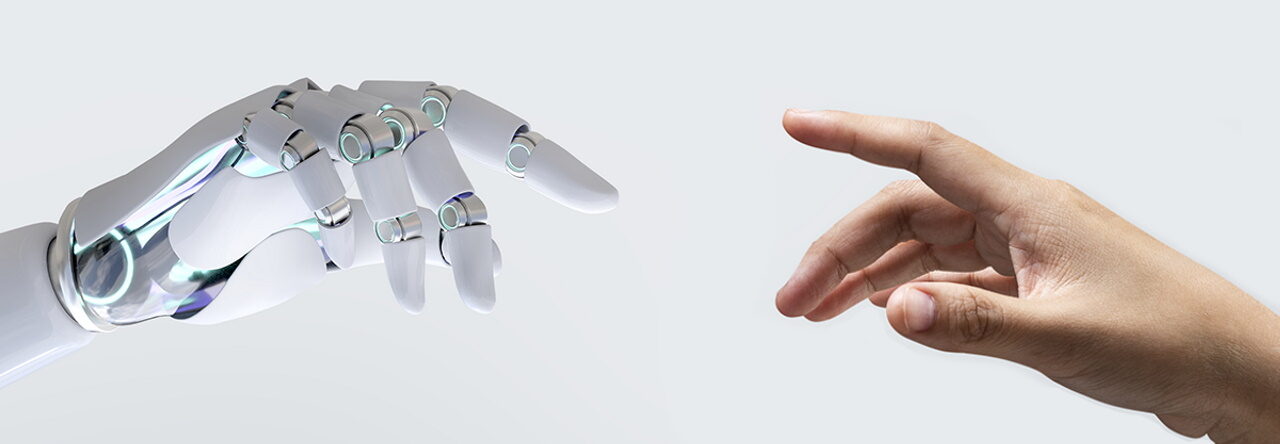Quando dico che l’era di “OpenAI come partner” è finita, lo intendo nel senso che OpenAI non si accontenta più di “fornire modelli” a Microsoft e altri: sta rilanciando il suo ruolo nel flusso di lavoro enterprise, trasformandosi da fornitore a concorrente pieno, da “accademia/start‑up” a “infrastruttura + applicazioni + servizi”. E questa trasformazione cambia le regole del gioco per tutti.
Una prima evidenza: OpenAI ha siglato un accordo con PwC che va oltre la semplice licenza PwC diventa rivenditore del livello enterprise di ChatGPT, con 100 000 utenti in forze. Parallelamente OpenAI sta lanciando pacchetti di “deployments + consulenza” a partire da $10 M per cliente — una chiara mossa per inserirsi nel cuore dei processi aziendali, non solo come add‑on.